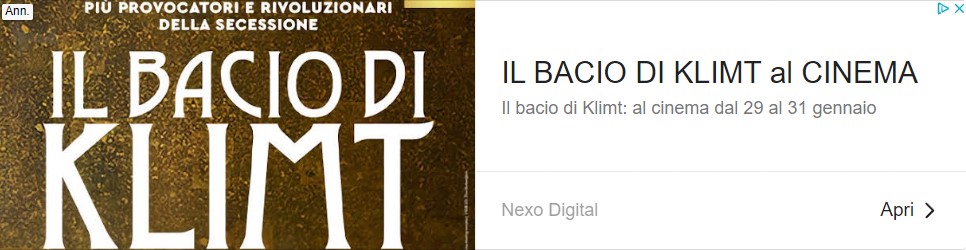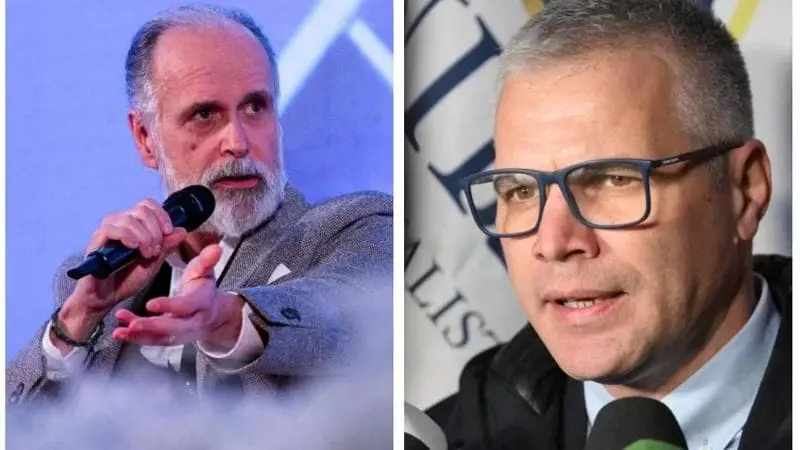Roberto Jucci, generale delle missioni segrete: “La P2, la Cia e il caso Moro: doveva essere distrutto, non volevano liberarlo”
«Il mio più grande rammarico sul caso Moro è quello di non avere capito che venivo strumentalizzato. Nel senso che mi avevano messo nell’angolo e mandato via da Roma per non vedere e non operare…». Il generale Roberto Jucci ha appena compiuto 98 anni e mantiene una memoria di ferro: ricorda tutto, ogni dettaglio della straordinaria carriera che lo ha visto protagonista della Prima e Seconda Repubblica. È stato al vertice del servizio sicurezza dell’Esercito, comandante dei Carabinieri, manager con Raul Gardini e Romano Prodi, tesoriere dell’Ulivo, presidente della Commissione per la riforma dei servizi segreti, infine commissario di governo in Sicilia e commissario di governo per la bonifica del fiume Sarno. Ha gestito missioni segretissime in Libia, Israele e Cina. Ha avuto un rapporto di fiducia con Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Bettino Craxi, Aldo Moro, Romano Prodi, Giovanni Spadolini e con tanti altri leader politici: gode di un rispetto enorme, perché considerato uomo delle Istituzioni. «Non sono mai stato sentito dalle Commissioni parlamentari sul caso Moro. Certo non avrei potuto dare una svolta decisiva alle conclusioni, ma qualcosa forse avrei potuto dire e contribuire alla ricerca della verità».
Che incarico aveva ai tempi del sequestro Moro?
«Ero solo un generale, ma per la mia esperienza internazionale quando si trattava di risolvere una questione delicata, ad esempio in Libia all’indomani del golpe di Gheddafi o aprire un canale riservato di trattativa tra Stati Uniti e Cina negli anni Settanta, mi chiamavano. Nel 1978 ero capo del Secondo reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito che si occupava di sicurezza, più spesso noto con la sigla Sios».
Che missione le affidò il ministro dell’Interno Cossiga?
«Mi chiese di creare un reparto dell’Esercito che potesse intervenire per liberare Moro quando fosse stata individuata la sua prigione. Dovevano operare con una precisione millimetrica per non rischiare la vita dell’ostaggio. Mi diede una settimana di tempo. Io ho preso gli incursori del leggendario Col Moschin, ho acquistato armi sofisticate in Gran Bretagna e in Germania e li ho fatti addestrare senza sosta in una base segreta all’interno della tenuta presidenziale di San Rossore. Cossiga mi domandava continuamente se erano pronti. Gli ho detto: “Ministro venga a vedere di persona”. Durante il viaggio per l’ispezione, senza preavviso, gli incursori fecero un agguato al suo corteo e immobilizzarono la scorta: a Cossiga stava venendo un infarto».
Cossiga aveva grande fiducia in lei: non l’ha chiamata a far parte del Comitato che gestiva le indagini su Moro?
«No. E non mi ha mai parlato di quello di cui discutevano. A Cossiga dissero di fare questo reparto ma non so se lo fecero per togliermi fuori dal campo a Roma. Perché io così passai praticamente tutti i giorni del rapimento in Toscana nella tenuta di San Rossore per predisporre questa squadra che non è mai entrata in azione. Andavo a Roma da Cossiga per riferire, mi intrattenevo con Ugo Pecchioli che era il rappresentante del Pci e aspettavamo che uscisse dalle riunioni del Comitato. A me chiedeva lumi sulla preparazione degli incursori; con Pecchioli faceva il punto della situazione. Mi tolsero di mezzo. E non so se questo fu fatto apposta. Perché allora gran parte dei vertici delle Istituzioni militari erano della P2. E su quella loggia io oggi ho molti pensieri: perché la P2 era espressione di un gruppo di potere di un Paese straniero, amico sicuramente ma che aveva altri interessi».
Parliamo degli Stati Uniti?
«Di centri di potere americani che operavano anche attraverso elementi della P2».
Lei ritiene che qualcuno abbia suggerito a Cossiga di allontanarla?
«Non ne ho certezze, ma noto che ai vertici degli Stati maggiori c’erano vari elementi della P2. Abbiamo una lista della P2, quella che hanno sequestrato i giudici Turone e Colombo nella perquisizione a Gelli, però sono convinto che quell’elenco non sia completo. Altri nomi vennero tenuti segreti forse perché avrebbero dovuto coprire quelli inclusi nella lista qualora fosse stata scoperta l’organizzazione massonica. Nell’elenco c’erano persone amicissime di altre che non comparivano nella lista. La cosa non mi è mai tornata. Bastava esaminare le carriere che hanno sponsorizzato per farsi un’idea… La P2 era uno Stato nello Stato!»
Ha mai conosciuto Licio Gelli?
«Mai».
Quali piduisti conosceva?
«Molti generali e prefetti erano della P2. Ricordo Federico Umberto D’Amato: era un’anguilla, da quando era vicecommissario della polizia imperava nell’Ufficio Affari Riservati del Viminale. Quando nel 1986 sono arrivato al vertice dei carabinieri, sono andato ad Arezzo e ho chiesto di Gelli al comandante provinciale dell’Arma. Lui mi disse: “Qui molti dei responsabili delle istituzioni sono stati voluti da Gelli. Il mio impegno più gravoso è stato far ricevere generali la domenica da Gelli”. Rimasi senza parole. Dovendo sostituirlo per un normale avvicendamento, ho dato il compito al responsabile della sicurezza del Comando Generale: era un ufficiale che aspirava a sedi più importanti e non capiva perché l’avessi mandato lì. Anni dopo gli ho spiegato che lo avevo scelto perché era addetto alla sicurezza del Comando Generale e quindi da ritenersi al di sopra di ogni sospetto».
Le hanno mai chiesto di entrare nella P2?
«No, mai. Quello che ho sempre ritenuto essere uno dei loro reclutatori, quando mi vedeva girava l’angolo. Mi conoscevano bene. Per entrare nella P2 si doveva essere persone disponibili ed io credo di non esserlo mai stato … Io ho avuto solo sempre un solo capo: quello delle Istituzioni. Quando capii che Giovanni Spadolini, diventato ministro della Difesa, riteneva che io, essendo amico di Andreotti e Cossiga, potevo non essere leale con lui, gli dissi: “Io ho un solo padrone, il ministro con il quale lavoro”».
E con Aldo Moro che rapporto ha avuto?
«Io per Moro avevo un affetto filiale. Ricordo ancora quando l’ho accompagnato nell’incontro con Gheddafi per discutere delle condizioni degli italiani in Libia e di altri problemi: il principale era l’importazione a prezzo speciale del greggio libico quando era prezioso, poiché il Canale di Suez era bloccato. Ho avuto con Moro vari colloqui, spesso mi chiedeva opinioni. Nel comunicato stampa che io scrissi dopo l’incontro con Gheddafi, dopo avermi dato delle direttive, cambiò una sola parola e mi chiese il permesso di farlo. Che uomo, non ne ho conosciuti altri come lui».
Lei è stato il primo referente italiano in assoluto di Gheddafi…
«All’indomani del golpe con cui prese il potere, il capo del servizio segreto Sid, l’ammiraglio Henke, mi mandò da Gheddafi. Henke aveva una particolare stima per il lavoro svolto insieme. Io non conoscevo nessuno in Libia. In poco tempo sono riuscito ad avere un colloquio con Gheddafi e dopo qualche mese a ottenere l’incontro tra lui e Moro che ha segnato la storia d’Italia di quel periodo. Pensi: minacciai Gheddafi che saremmo sbarcati in Libia. Un bluff: se avesse fatto “vedo”, mi sarei ritrovato in una situazione molto difficile. Ci credette ed ebbe fiducia in me, spesso mi chiese consiglio: forse gli salvai la vita o il potere con l’operazione Hilton che ha sventato un altro golpe. Dal 1972 in poi questo rapporto con Gheddafi non l’ho avuto più, poiché il governo mi ha sostituito in questi contatti. L’ho rivisto quattro volte per missioni particolari da parte del governo: l’ultima nel 1980 per discutere la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. Poi non l’ho più incontrato: né lui, né i suoi collaboratori».
Non ha pensato di rivolgersi a Gheddafi per la liberazione di Moro?
«Nessuno mi chiese di operare in questo senso. E io ho avuto contatti con Gheddafi soltanto per missioni che mi sono state affidate dal governo. Nel sequestro Moro non sono stato un attore, ma solo una comparsa».
Se fosse stato un attore, cosa avrebbe fatto?
«Certamente, avrei fatto pedinare coloro che andavano a portare le lettere di Moro al suo segretario Freato e ad altri soggetti. Avrei cercato di trovare supporto nei Paesi arabi che forse avrebbero potuto trovare un canale utile per la sua liberazione. Avrei tentato l’intentabile per salvarlo. Probabilmente non ci sarei riuscito, ma avrei tentato di tutto».
I nostri apparati di sicurezza nel 1978 erano privi di unità specializzate. C’erano le squadre per gestire i pedinamenti?
«Senz’altro. Quando entrai nel Servizio, siccome non esisteva ancora la scuola interna, feci fare un vademecum operativo e dei corsi per il personale: per il pedinamento mi servii degli insegnamenti del Mossad israeliano. C’erano decine di uomini preparati per questo compito. Le mie considerazioni riguardano anche il comprensorio di via dei Massimi, dove abitavano alti prelati del Vaticano e c’era un via vai di brigatisti: era forse amministrato da un dirigente dello Ior, il padre di monsignor Antonello Mennini, che si dice abbia confessato Moro durante la prigionia. Un’altra figura che sarebbe stato opportuno pedinare».
Perché non furono ordinati questi pedinamenti?
«Non ci fu un coordinamento. E purtroppo ci si affidò a quel gruppo che consigliava Cossiga per portare avanti le operazioni. Cossiga era consigliato da un uomo mandato dagli Usa e dalla commissione composta in gran parte da piduisti. Tutte persone che a mio avviso volevano che le cose andassero in una maniera diversa da quella che tutte le persone oneste chiedevano. Moro doveva essere distrutto politicamente e fisicamente: se Moro fosse sopravvissuto la politica dell’Italia avrebbe avuto uno sviluppo diverso da quello che è stato. Credo che si sarebbe potuto liberare Moro, se tutte le istituzioni avessero operato in questa direzione. Ma l’apertura di un governo, sostenuto da Moro, formato da comunisti e democristiani era osteggiata sia dagli Usa e sia per altri motivi dall’ex Unione Sovietica».
L’ha mai detto a Cossiga?
«Cossiga certamente ha agito in buona fede nell’assegnarmi il compito di preparare gli incursori perché lui ci teneva tanto che nella liberazione Moro non venisse colpito. Lui non sapeva che questo reparto non sarebbe mai entrato in azione. Ma voleva arrivare alla liberazione, voleva assolutamente salvare Moro: su questo non ho dubbi».
Ma voi siete rimasti molto legati, ne avrete discusso…
«Cossiga dopo la morte di Moro diede le dimissioni e scomparve. Dopo alcuni giorni venni a sapere dove si trovava: era chiuso in un appartamento nei pressi di piazza San Silvestro, un sottufficiale della Marina gli portava il cibo. Lo andai a trovare più volte. Mi guardava muto per molti minuti. Poi mi diceva: “Forse potevo fare di più”. Per lui era un’ossessione, che credo gli abbia segnato la vita».
E con Andreotti ne ha mai parlato?
«No, ho mantenuto un ottimo rapporto con lui. Era una persona intelligentissima e dava soggezione. La segretaria mi chiamava la sera per un appuntamento alle sette del mattino successivo e mi chiedeva di sintetizzare un argomento in dieci minuti. Io lavoravo per ore la notte per prepararlo: dopo dieci anni Andreotti tirava fuori un foglietto e ricordava ancora tutto di quel colloquio, che io forse avevo dimenticato. Lo stesso Cossiga aveva quasi soggezione di lui…».
Torniamo a quei «centri di potere americani che operavano attraverso elementi della P2». Lei era tenuto in alta considerazione dall’intelligence americana: gli aveva anche consegnato la più importante fonte sui servizi segreti del Patto di Varsavia…
«Non fu un mio merito: nel 1968 quel generale dei servizi cecoslovacchi si è presentato a Trieste. Io ho solo compreso quanto valeva. Io ho avuto rispetto per gli americani e loro mi hanno sempre rispettato. In quella circostanza evidentemente non condividevo le loro posizioni».
Due anni dopo le chiesero aiuto per liberare gli ostaggi americani a Teheran e lei ottenne informazioni preziose. Ma su Moro non l’hanno mai consultata?
«Lo ripeto: mi sono formato la convinzione che su Moro non avessimo la stessa visione».
Tutti parlano del ruolo della Cia, ma in Italia c’era una forte presenza dell’intelligence militare Usa.
«L’intelligence militare Usa ha operato a volte in una maniera assai discutibile: eravamo un alleato lontano dallo loro terra, con visioni non sempre coincidenti. E purtroppo ci sono stati italiani che hanno operato seguendo le loro indicazioni per obiettivi che forse non dovevano essere né fatti, né pensati».
A cosa si riferisce?
«A Gladio, per esempio: doveva essere fatta, ma andava gestita in maniera diversa. Nelle nostre pianificazioni, in caso di invasione, era previsto che abbandonassimo parte del territorio per posizionarci su linee più difendibili. Se qualcuno ha usato Gladio per altri fini è sua responsabilità personale».
Nel 1978 Moro non è stato trovato, mentre quattro anni dopo la prigione del generale americano James Dozier è stata individuata e lo hanno liberato con un blitz.
«Uno volevano liberarlo; sull’altro ho i miei dubbi. Ma aggiungo di più: non volevano trovare Moro né loro, né il Kgb. Anche i servizi sovietici in quel momento seguivano le stesse strategie. Ricordo l’arresto di Morucci e Faranda a casa di Giuliana Conforto, che dopo pochi mesi fu messa in libertà nonostante i reati a lei attribuiti avrebbero forse richiesto pene più elevate. Chi era Giuliana Conforto? La figlia di un agente del Kgb di lunga data, Giorgio Conforto, il quale ha sempre lavorato dietro le quinte per uno dei burattinai dei nostri servizi, quel Federico Umberto D’Amato di cui ho già parlato. È stato approfondito il perché di questo trattamento per Giuliana Conforto?».
E lei generale, dove tiene i suoi archivi?
«Non ho mai preso un singolo foglio riservato dagli uffici che ho guidato. Ho tutto qui, nella mia testa».
Condividi questo contenuto: