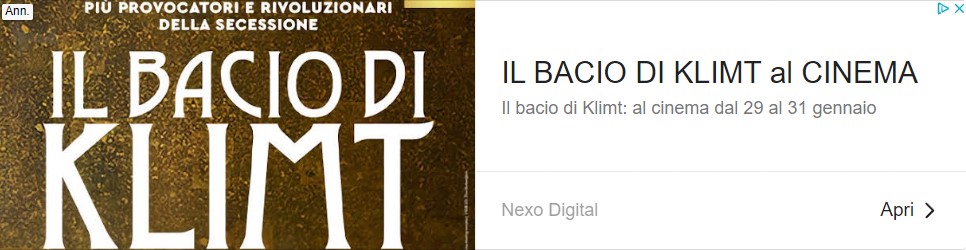Sempre più bravi a fare diagnosi, ma non sempre è un bene: ecco perché
Oggi nessuno può ritenersi del tutto sano, con l’abbondare di esami diagnostici a cui siamo sottoposti e l’estendersi delle definizioni di malattia, fenomeno particolarmente accentuato negli ultimi trent’anni. Una neurologa di lungo corso, Suzanne O’Sullivan, denuncia gli effetti negativi per l’individuo e per la società di questa tendenza nel saggio The Age of Diagnosis (ed. Hodder & Stoughton)
Cos’è la sovradiagnosi, dottoressa O’Sullivan?
“Molti pensano che questo termine indichi diagnosi sbagliate, ma non è così: indica, invece, il momento in cui una diagnosi medica può causare più danni che benefici. Questo può succedere in diversi modi, per esempio attraverso l’iper-rilevamento: oggi abbiamo tecnologie come risonanze magnetiche e test genetici che permettono di rilevare “anomalie” anche vent’anni prima che possano diventare sintomatiche, e questo può pesare molto su una persona. L’iper-rilevamento può trovare cose che non avrebbero mai avuto bisogno di trattamento. Io ho frequentato la scuola di medicina a cavallo tra gli anni ’80 e ’90: allora le uniche tecnologie per vedere dentro il corpo umano erano i raggi X e la Tac, ma non venivano usate alla leggera perché si era consapevoli di somministrare al paziente una dose di radiazioni. La risonanza magnetica non ha quel problema, e oggi se ne abusa: è facile, economica e sempre più sensibile. Rileva sempre più cose”.
Risonanza magnetica full body scan: chi deve farla e a cosa serve
E perché questo sarebbe un problema?
“Da neurologa so che tutti, specialmente dopo i 60 anni, hanno qualche piccola anomalia nella risonanza magnetica del cervello, e così ci troviamo costantemente a dire ai pazienti che c’è qualcosa nella loro risonanza, ma non è nulla di preoccupante. La diagnosi dovrebbe essere sempre clinica. Il medico dovrebbe avere una domanda precisa quando prescrive un esame. “Questa persona ha difficoltà a camminare: potrebbe essere il disturbo X?”. Se, invece, si fanno scansioni in modo casuale e si trova qualcosa, interpretarlo è un problema. Negli Stati Uniti molte persone fanno “scansioni del corpo intero” solo per verificare se stanno bene. Ma è un errore enorme, perché non sappiamo come interpretare i risultati di quei test, se non c’è a monte un sintomo clinico”.
IA in medicina? Non fidiamoci troppo
Che cos’è invece la iper-medicalizzazione?
“Con iper-medicalizzazione indico il fatto che stiamo espandendo sempre di più i confini delle malattie per etichettare sempre più persone come malate. Ciò che oggi chiamiamo “sindrome da deficit di attenzione” magari in passato non avrebbe ricevuto alcuna etichetta. Oggi presumiamo che identificare e trattare forme più lievi di un problema possa essere utile: il fenomeno della sovra-diagnosi suggerisce che non sempre è necessariamente così, e non è detto che sia sempre d’aiuto”.
Come è iniziata, storicamente, la tendenza a sovra-diagnosticare?
“È il risultato di un percorso iniziato con buone intenzioni. Pensiamo alle diagnosi odierne di autismo. Negli anni ’70 e ’80, molte persone con bisogni educativi speciali o difficoltà psicologiche venivano trascurate o stigmatizzate. Così la società ha cercato di rimediare ampliando i criteri diagnostici per includere anche le forme più lievi di disturbo. E gli scienziati hanno modificato i criteri diagnostici per includere le persone che si trovano in quella fascia più lieve. Ma questi aggiustamenti sono andati troppo oltre e stiamo riconoscendo come autistiche persone che non hanno compromissioni sufficienti per essere realmente considerate autistiche”.
Tumore prostata, lo studio: in Europa troppe diagnosi e trattamenti non necessari
Quali criteri dovrebbe rispettare, secondo lei, una diagnosi corretta?
“Una diagnosi di autismo dovrebbe basarsi su una compromissione reale delle funzioni quotidiane, come la difficoltà ad andare a scuola o a gestire la vita autonoma. Oggi invece si diagnosticano persone solo per tratti di personalità come l’introversione o la timidezza. È stato un processo nato con buone intenzioni, ma si è spinto troppo oltre e si è arrivati perfino a parlare di autismo “mascherato”, cioè senza alcun segno visibile”.
Cosa pensa delle diagnosi predittive, come i test genetici per Alzheimer o Parkinson?
“Mi preoccupano molto. Sapere con dieci anni d’anticipo che potresti sviluppare una malattia per la quale non c’è cura può solo generare ansia. Le persone sottovalutano quanto cambia il rapporto con il proprio corpo. Ogni dimenticanza diventa un presunto sintomo. Inoltre, oggi siamo protetti dalla privacy, ma in futuro queste informazioni potrebbero diventare richieste per assicurazioni, mutui o lavoro”.
Come si può migliorare la situazione?
“Innanzitutto, servono definizioni più rigorose di cosa sia un disturbo medico. La diagnosi deve restare uno strumento clinico, non un’etichetta sociale. Poi dobbiamo iniziare a riconoscere che non tutte le difficoltà richiedono una medicalizzazione. Esistono forme di sofferenza che possono e devono essere affrontate con strumenti educativi, sociali, culturali, non necessariamente clinici. E infine, dobbiamo essere più onesti anche nella comunicazione pubblica: una diagnosi non è sempre un passo avanti. A volte può diventare un ostacolo”.
Condividi questo contenuto: