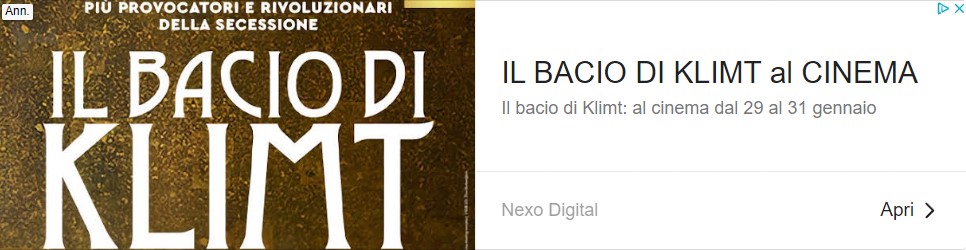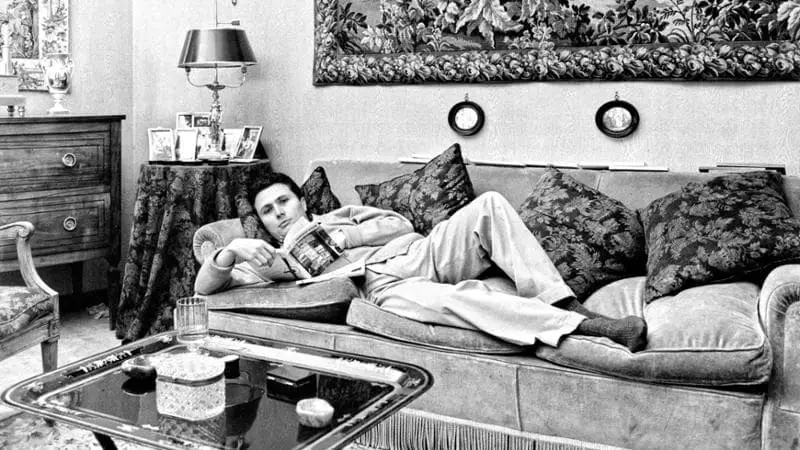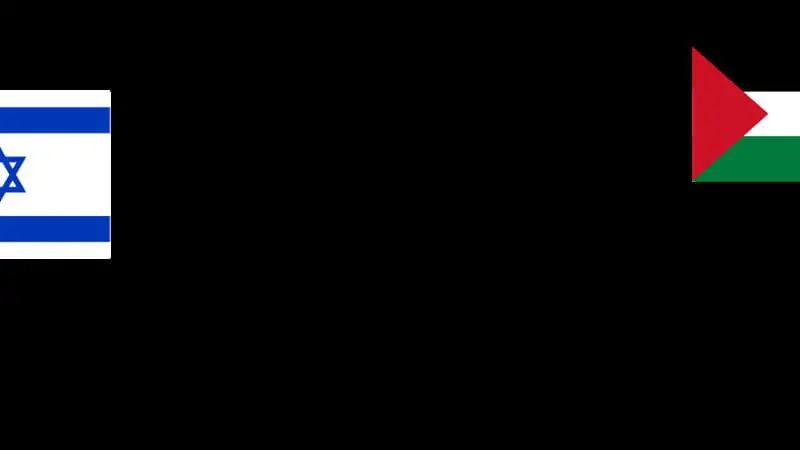Scagioniamo Socrate il processo è da rifare
Due o tre anni fa, una svagata professoressa della West Georgia ha avanzato una sua originale motivazione della condanna subita da Socrate ad Atene, ossia misconduct: il maestro andava a letto con i suoi studenti, per questo fu condannato. Insomma, uno dei padri della filosofia occidentale, se non addirittura il padre, viene trattato alla stessa stregua di un professore di college dal comportamento “improprio”. Ecco perché non ho mai amato la cosiddetta attualizzazione dei classici. In realtà, la condanna e la morte di Socrate hanno da sempre costituito uno dei problemi più spinosi che siano stati dibattuti fra storici e filosofi, e le spiegazioni che ne sono state date sono molteplici. Fra le più correnti sta comunque questa, ricavata da uno dei principali capi d’accusa rivolti a Socrate: egli, si dice, «non credeva negli dèi».
Identikit di Socrate il ribelle
Dunque, si è concluso, le antiche società politeistiche non erano affatto liberali come si dice, esistevano obblighi che riguardavano la fede religiosa tanto quanto ne esistono nelle religioni monoteistiche; e trasgredirli comportava la morte. Insomma, anche ad Atene si poteva morire per reati di opinione in campo religioso. Per dissipare l’equivoco, però, basta conoscere un po’ meglio la lingua greca. Quando si accusa Socrate di ou nomízein toús theoús, non si intende che il filosofo non “crede” negli dèi, ma che non li “onora” nei modi dovuti e propri della città. Perché questo significa nomízein toús theoús, dedicare agli dèi il culto che il nómos, ossia la legge, la tradizione, prescrive.
Socrate non era un ateo, un miscredente, ma uno che violava le norme relative alla pratica religiosa. Che poi non era neppure vero, visto che Senofonte, per difenderlo, affermava che il filosofo era solito sacrificare sugli altari pubblici; mentre lo stesso Socrate, prima di bere la cicuta, ricorda a Critone di sacrificare un gallo al dio Asclepio.
L’anteprima. Bobbio è il nostro Socrate
Su questo e su tanti altri luoghi comuni nel campo della religione greca, fa luce oggi il bel libro di Carmine Pisano, La religione dei Greci (Carocci). Un’opera snella ma davvero preziosa, non solo perché tiene conto degli enormi progressi che gli studi sulla religione dei Greci hanno compiuto negli anni duemila, per opera di studiose e studiosi che vi hanno contribuito da tutta Europa; ma soprattutto perché il punto di vista scelto da Pisano per “entrare” nei testi e nelle testimonianze archeologiche è finalmente quello antropologico. Ossia attento a ricostruire il modo in cui i Greci stessi pensavano e agivano nel campo religioso, senza sovrapporre alle diverse pratiche e credenze il peso di categorie scientifiche estranee alla grecità. Quando non sono, per soprammercato, anche desuete. Il fatto è che per studiare le religioni antiche, sia che si parli della greca che della romana, occorre liberarsi dalla prospettiva che la parola “religione” da duemila anni suscita nella nostra cultura, plasmata dal cristianesimo. Ossia quel rapporto individuale, personale, con Dio, che può sfociare nel misticismo e nell’adorazione silenziosa.
Niente di tutto questo, per un greco la eusébeia non è “pietà” ma, come ben spiega Pisano, osservanza della prassi sancita dalla religione civica; mentre la deisidaimonía non è la “superstizione”, ossia un insieme di credenze e pratiche non riconosciute dal credo ufficiale, ma semmai l’eccesso di scrupolo religioso, una esasperata dedizione al culto. Che poi, soprattutto, in Grecia il credo non c’è, e Pisano lo spiega molto bene. Nell’Ellade, come a Roma, non vi era il Libro, dalle cui scritture viene estrapolato tutto ciò che è necessario sapere e fare a proposito del Dio unico. Per gli antichi la religione fa tutt’uno con l’insieme delle norme di carattere civico, leggi e tradizioni, composte oralmente e spesso oralmente anche tramandate, attraverso il sapere dei sacerdoti. Certo, Omero ed Esiodo furono “maestri” di teologia per i Greci, nel senso che Omero “fece conoscere” gli dèi, come dice Erodoto, mostrandone sembianze e attribuzioni; mentre Esiodo ne tracciò una genealogia. Ma si tratta di poeti, non di profeti: e le loro opere non costituirono mai qualcosa di simile a un libro sacro.
Il libro
La religione dei Greci. Tra storia e antropologia di Carmine Pisano (Carocci, pagg. 164, euro 17)
Condividi questo contenuto: