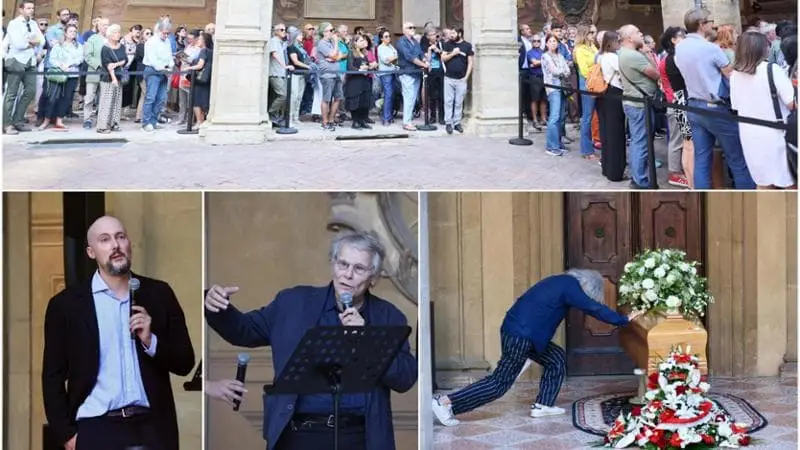Storie di storia / 88. Tre storie sul Nilo
Nilo, Yangtse, Tigri, Eufrate, Tevere: fin da piccoli, maestri elementari e sussidiari ci hanno insegnato che non esistono grandi civiltà senza un fiume. Sorgente di acqua potabile o fonte per l’irrigazione dei campi, il fiume costituisce spesso anche un mezzo di trasporto essenziale per i commerci o una via di accesso al mare. Vedute straordinarie ritratte da artisti e ponti leggendari raccontati da poeti rappresentano specchi che riflettono millenni di storia. Questi racconti, dedicati al Nilo, proseguono una serie di storie legate ai grandi fiumi del mondo. Buona lettura!
LA STORIA
IN PRINCIPIO ERA IL FIUME
Tre storie sul Nilo
Di Davide De Leo (Linguista, PhD)
Il Nilo. Culla di civiltà per antonomasia, ne apprendiamo il nome sin da piccolissimi, nei sussidiari delle scuole elementari.
Uno dei mille aspetti del fascino esercitato dal Nilo è il mistero. Pur essendo uno dei fiumi più ambìti dai ricercatori e probabilmente il più studiato e conosciuto, esiste un’aura di mistero sul primato di fiume più lungo del mondo e sulle sorgenti. È fonte di vita per più di 300 milioni di persone, ora come lo fu in passato. Da circa 5.000 anni significa acqua potabile, cibo e mezzo di navigazione, oltre a terra fertile. Bagna città importantissime: oltre al Cairo, anche Alessandria e Khartoum, Jinja, Giuba e Kampala, fondate per approfittare delle sue preziose acque.
Qui di seguito sono raccontate tre storie legate al Nilo. Successivamente, 100 fatti e curiosità sul fiume.
LA GRANDE DIGA DEL RINASCIMENTO ETIOPE
L’acqua contesa del Nilo
Fino a un secolo e mezzo fa, il Nilo straripava ogni anno da agosto a ottobre in un territorio assetato, depositandovi un terriccio ricco di nutrienti, che formava una fanghiglia molto fertile, il limo, perfetta per le coltivazioni. Da ottobre in poi la portata del Nilo si riduceva decisamente, fino a un sesto rispetto ad agosto. Numerosi i periodi di siccità, con livelli del fiume molto bassi. Da sempre vi è il desiderio, o l’ossessione, da parte di chi vive nei pressi del Nilo, di controllare l’acqua, arginarla e renderla disponibile per il maggior tempo possibile. Alla fine del XIX secolo, al tempo della dominazione ottomana sull’Egitto, Mehmet Ali prima e suo nipote Ismail dopo, intrapresero una serie di opere per controllare meglio l’acqua del fiume, in particolare la prima diga eretta tra il 1833 e il 1884 a valle del Cairo. L’opera, insieme ad altre imprese monumentali, portò l’amministrazione egiziana alla bancarotta, e alla conseguente tutela della Gran Bretagna. I britannici, nel 1902, costruirono la prima diga di Assuan, sulla prima cataratta del Nilo, alta 36 m e lunga quasi 2 km. La diga, la più grande mai costruita fino ad allora, aveva lo scopo di rendere più regolare la coltivazione e la raccolta (e quindi l’importazione) del cotone in Gran Bretagna. Nel 1952, Nasser fece costruire una seconda diga, lunga più del doppio (4 km), che ha permesso di raddoppiare e talvolta di triplicare le colture in varie zone lungo il Nilo. Inoltre, questa diga produce 2,1 GW di elettricità, il 10% dell’energia prodotta nel Paese. L’enorme diga controlla quindi il flusso del fiume per generare elettricità, irrigare le coltivazioni e fornire acqua potabile alle zone abitate, ma penalizza la portata del fiume (-14%) a causa dell’evaporazione e la distribuzione naturale di limo, spingendo all’utilizzo di fertilizzanti chimici.
Nel 1959, l’Egitto (o meglio, la Repubblica Araba Unita, entità statuale che riunì per pochi anni Egitto e Siria) firmò un accordo con il Sudan per la suddivisione delle acque del Nilo. L’accordo prevedeva il 75% della portata d’acqua a favore dell’Egitto e il 25% a favore del Sudan. L’Egitto si attribuì un diritto di veto nei confronti di qualsiasi progetto che comportasse una diga o una stazione di pompaggio o una qualsiasi opera di irrigazione.
Forte dell’accordo, il Sudan costruì anch’esso due dighe, a Roseires sul Nilo Blu e a Khashm el-Girba sull’Atbara, affluente del Nilo, che permisero di creare nuove coltivazioni grazie a nuove possibilità di irrigazione. Inoltre, iniziò una canalizzazione del Nilo Bianco, a Jonglei, che si trovò ben presto al centro dei conflitti che finirono per portare alla scissione tra Sudan e Sudan del Sud nel 2011. La popolazione meridionale, infatti, già indispettita da quella che percepiva come un’iniqua ripartizione delle risorse tra nord e sud, approfittò della presenza del Canale di Jonglei nel proprio territorio per proclamare la scissione e poterlo controllare.
Ma questa storia riguarda soprattutto l’Etiopia, che si sentì esclusa dall’accordo del 1959, che decideva le sorti del fiume che l’attraversa senza prendere in considerazione i Paesi a monte. Dall’Etiopia nascono il Nilo Blu, ma anche due affluenti, l’Atbara e il Sobat: in tutto, l’86% della portata del Nilo. Il Primo ministro Meles Zenawi, salito al potere nel 2010, cercò di ribilanciare il peso delle decisioni sul Nilo a favore dei Paesi a monte. A tal fine firmò accordi con Uganda, Kenya, Ruanda, Burundi e Tanzania, una netta rottura geopolitica col passato. Quindi, nel 2011, approfittando dei moti rivoluzionari in Egitto, lanciò il progetto gigantesco della Diga del Rinascimento.
Questa, da poco ultimata, è la più grande diga di tutta l’Africa. Alta 170 metri e lunga 1.780, ha iniziato a produrre energia all’inizio del 2022, ma una volta a regime dovrebbe generare più di 6.000 megawatt di elettricità. La capacità è di 16.153 GWh/anno, che consentiranno di dare energia elettrica a 40 milioni di famiglie. L’hanno costruita l’italiana Webuild per l’infrastruttura civile, mentre le turbine sono state fornite da Voith Hydro Shanghai e China Gezhouba Group.
L’opera avvelena i rapporti tra Addis Abeba, il Cairo e Khartoum. L’Egitto si ritiene da sempre il guardiano del Nilo e, saputo del progetto, aveva minacciato una “instabilità senza precedenti” se una sola goccia d’acqua fosse stata prelevata dal Nilo. Questo perché il Cairo considera la diga una minaccia esistenziale. In una regione già sottoposta a tensioni esasperate come quella del Corno d’Africa, questa nuova miccia potrebbe far deflagrare un ennesimo conflitto.
Nel 2015 è stato quindi firmato un accordo tra Egitto, Etiopia e Sudan, nel quale le parti si impegnavano a collaborare e a non arrecare danni alle controparti, in materie cruciali quali la portata d’acqua da rilasciare dalla diga e le modalità di riempimento della diga. Questo non doveva essere troppo rapido per evitare di trattenere troppa acqua a scapito dei Paesi a valle, ovvero Sudan ed Egitto; oggi si può dire che è avvenuto in modo piuttosto indolore, almeno a dire degli etiopi, grazie a qualche stagione di pioggia generosa tra il 2020 e il 2024, anno in cui il riempimento è stato completato. Ora però l’Egitto capisce che l’Etiopia può prendere decisioni unilateralmente, trovandosi a monte degli altri Paesi, e resta aspramente critico del progetto. Vi sono state due operazioni militari da parte egiziana, Eagle I e Eagle II. Nella prima, nel maggio del 2011, le forze speciali egiziane avevano preso il controllo di Merowe, città sudanese sul Nilo, in posizione strategica, a metà strada tra Egitto ed Etiopia. Da Merowe facevano volare arei militari fino alla frontiera dell’Etiopia per far avvertire la loro presenza minacciosa. Controllavano peraltro la frontiera tra Sudan ed Etiopia con le forze speciali e svolgevano azioni di sabotaggio, con la collaborazione di alleati internazionali. Hanno coinvolto il Consiglio di sicurezza dell’ONU nel tentativo di fermare la GERD, senza successo. Nell’aprile del 2023 forze speciali sudanesi hanno però ripreso il controllo di Merowe e della frontiera.
Peraltro, la Diga si trova in una zona di ribelli, ostili al governo centrale, massacrati a più riprese da Addis Abeba. Molti villaggi sono stati evacuati senza ridistribuire le popolazioni rimaste senza casa. Il governo cerca di ristabilire i contatti con i locali, senza troppo successo.
Il progetto colossale è stato finanziato in parte dall’emissione di titoli obbligazionari etiopi, ma in ogni caso attraverso finanziamenti quasi esclusivamente locali. Secondo una dichiarazione del luglio del 2025 del Vicedirettore del Progetto, Fikrte Tamir, non si è fatto ricorso a linee di credito estere o finanziamenti di alcun tipo provenienti dal di fuori del Paese per la costruzione della diga. Tamir ha sottolineato che la GERD è un’opera nazionale unica, finanziata, costruita e difesa da cittadini etiopi. L’opera rappresenta un simbolo duraturo di unità, patriottismo e determinazione.
Dal lancio del progetto, più di 20,1 mld di birr (più di 120 mln di euro) sono stati raccolti da fonti domestiche, oltre a oltre 1,6 mld di birr provenienti da cittadini etiopi all’estero.
Il costo della diga supera i sei miliardi di euro, ben oltre la metà del bilancio statale. L’opera ha quindi riunito gli etiopi, un mosaico di etnie, nell’orgoglio nazionale di costruire la Diga del Rinascimento, che inizia a dare energia elettrica a una popolazione che per il 65% ne è sprovvista; di più, sta consentendo ad Addis Abeba di esportarla per la prima volta nella storia, soprattutto in Sudan, a Gibuti e in Kenya, raccogliendo preziosa valuta estera.
La diga si trova a 20 chilometri dalla frontiera del Sudan, ma per ora non funziona a pieno regime. Molti gli ostacoli posti sulla strada del completamento dell’opera. Nei primi anni di progettazione e costruzione, ben pochi finanziamenti sono arrivati dall’estero, per paura di inimicarsi l’Egitto, partner strategico e militare, fondamentale per l’area. Poi, corruzione e pratiche illegali hanno frenato lo sviluppo della diga. Il responsabile del progetto, l’Ing. Simegnew Bekele Aynalem, è stato trovato morto nella sua auto nel 2018 ad Addis Abeba, con una pistola in mano, in una probabile messinscena di un suicidio.
Alcuni numeri sulla GERD: 170 metri di altezza · 1800 metri di lunghezza · capacità del bacino di 74 miliardi di m3 · superficie del bacino di 1875 km2 · organico di 25.000 persone · risparmio di 1,3 milioni di tonnellate di CO2 l’anno · capacità installata di 5150 MW · produzione energetica di 15.700 GWh/anno · 10 milioni di m3 di cemento · il più grande progetto idroelettrico africano
Fonte: Webuild SpA/France 24
LA BATTAGLIA DEL NILO
Nelson contro Napoleone
La Battaglia del Nilo, detta anche Battaglia della Baia di Abukir, fu combattuta i primi due giorni di agosto del 1798. La flotta britannica, condotta dal contrammiraglio Sir Horatio Nelson, distrusse la flotta francese nella Baia di Abukir, nel delta del Nilo. Fu una delle battaglie decisive delle guerre napoleoniche negli anni post-rivoluzionari.
La campagna d’Egitto francese, lanciata nel 1798, si iscriveva nella lotta per la supremazia tra Francia e Gran Bretagna. Dopo cinque anni sanguinosi, gli eserciti della Repubblica francese avevano sconfitto quasi tutti i nemici, conquistando Paesi Bassi, Renania e Italia del nord. Restava però il rivale di lungo corso, la Gran Bretagna, che rifiutava testardamente ogni armistizio. La partita si giocava su vari scacchieri, dalle Americhe ai Caraibi, dall’Africa all’India, oltre all’Europa naturalmente. La Guerra dei sette anni (1756-1763) aveva visto prevalere i britannici, che esercitavano da allora un’egemonia sul subcontinente indiano. Le ostilità erano riprese con le guerre rivoluzionarie francesi nel 1792. Il Generale Napoleone era l’astro nascente del neo-esercito rivoluzionario. Per questo motivo il Direttorio assecondò il suo coraggioso piano, che aveva l’obiettivo di conquistare l’Egitto e chiudere la rotta verso l’India che transitava da Egitto, Mar Rosso e Oceano Indiano. Stabilita una colonia francese in Egitto, inoltre, Bonaparte sperava di creare una base dalla quale poter lanciare un attacco contro l’India britannica e conquistarla. La massiccia flotta francese era composta da 13 vascelli di linea, 13 fregate, 23 corvette e sloop e centinaia di navi da trasporto di varie dimensioni. L’ammiraglia della flotta era la colossale L’Orient, una nave da guerra a tre ponti e 124 cannoni, forse la più potente del mondo all’epoca. Il comando generale fu affidato al viceammiraglio François-Paul Brueys d’Aigalliers, un ufficiale navale di 45 anni, di origine aristocratica. Solo Brueys e pochi dei suoi ufficiali furono informati del vero scopo della spedizione; per mantenere l’effetto sorpresa, Bonaparte fece di tutto per nascondere la destinazione della flotta, persino ai suoi stessi uomini. La discrezione di Bonaparte pagò: le spie inglesi vennero presto a sapere dell’enorme forza di spedizione a Tolone, composta da un esercito di 38.000 soldati, ignorandone però la destinazione. La intuì il ministro della guerra britannico, Henry Dundas, che fu però deriso dai colleghi, che lo invitarono a guardare meglio l’atlante e a tener conto delle distanze.
A 39 anni, Nelson era il più giovane contrammiraglio della Royal Navy, ma si era già costruito una reputazione di rilievo e portava sul corpo le cicatrici delle battaglie; nel 1794 aveva perso l’uso dell’occhio destro durante l’assedio di Calvi e tre anni dopo era stato ferito nella battaglia di Santa Cruz de Tenerife, con conseguente amputazione del braccio destro. Appena ristabilitosi dalla perdita del braccio, Nelson salpò con la sua ammiraglia Vanguard il 2 maggio, con l’ordine di tenere d’occhio la flotta francese a Tolone. Ma il 12 maggio, mentre la squadra di Nelson era ancora al largo di Tolone, una violenta tempesta disperse le navi e disalberò la Vanguard. Nelson si diresse in Sardegna per le riparazioni; al suo ritorno, il 27 maggio, i francesi erano già salpati. Da qui iniziò una caccia alle navi francesi nel Mediterraneo, questa volta per catturarla, affondarla, bruciarla o in ogni caso distruggerla.
I francesi, nel frattempo, arrivarono prima al largo della costa di Malta il 10 giugno. La invasero e la saccheggiarono. Il 19 giugno salparono per Alessandria, prendendo una rotta lunga attorno a Creta per depistare gli inseguitori britannici. Come ulteriore precauzione, Brueys ordinò di sequestrare e trattenere ogni nave mercantile incontrata fino all’arrivo in Egitto per paura che i rispettivi equipaggi potessero informare i britannici.
Nelson, sfiorati i francesi nascosti da una fitta nebbia, arrivò ad Alessandria il 28 giugno, ma non vide alcuna traccia della flotta francese. Rendendosi conto di aver perso le tracce del nemico, ebbe quasi un crollo nervoso; attese 24 ore e salpò nuovamente da Alessandria.
Elusa la Royal Navy, i francesi ebbero gioco facile a sbarcare in Egitto, sempre ad Alessandria, il 1° luglio, terrorizzando gli alessandrini, che non riuscivano più a vedere il mare all’orizzonte, ma solo cielo e navi. Il giorno successivo conquistarono la città e passarono qualche giorno a sbarcare truppe e materiali. Siccome il porto di Alessandria non era abbastanza profondo per le navi da guerra francesi, Bonaparte ordinò a Bruyes di ancorare nella Baia di Abukir, nel delta del Nilo, che sembrava offrire una difesa ideale per la flotta.
Mentre la flotta francese si posizionava ad Abukir, Nelson navigava a ovest di Creta, in cerca del nemico. Dopo una sosta in Sicilia per fare rifornimento, i britannici virarono verso il Peloponneso il 28 luglio. Qui, infine, Nelson ebbe un po’ di fortuna. Il governatore locale ottomano era stato informato dell’invasione francese dell’Egitto. Quando poi la flotta di Nelson intercettò un brigantino francese in rotta verso l’Egitto carico di vino, Nelson non ebbe più dubbi e si diresse verso Alessandria, dove arrivò la mattina del 1° agosto. La bandiera tricolore francese era ben visibile sulla città, ma nessuna traccia delle navi. Nelson spedì la Zealous e la Goliath a battere le coste in cerca della flotta di Napoleone. Alle 14.30, le vedette della Zealous avvistarono la foresta di vele francesi ancorate nella Baia di Abukir. La Zealous segnalò quanto aveva scoperto e alle 16 la maggior parte dei vascelli britannici entrò nella baia. A bordo della Vanguard, Nelson cenò con i suoi capitani, che diventarono famosi con il nome di “Nelson’s Band of Brothers”. Brindando, fece una previsione: l’indomani sarebbe stato diretto verso la Camera dei Lord o l’Abbazia di Westminster, dove sono sepolti gli eroi militari. Quando i francesi videro le navi francesi, gran parte del personale era a terra, a scavare pozzi per trovare acqua dolce. Brueys ordinò di tornare a bordo delle navi, ma senza fretta: con così poche ore di luce, sembrava improbabile un attacco dei britannici al buio. Ma Nelson aveva un vento favorevole da nordovest, colse l’occasione e segnalò alle navi di attaccare. Le navi francesi erano legate l’una all’altra, credevano di aver creato un baluardo sicuro, ma erano un po’ troppo distanti da riva. La Royal Navy riuscì quindi ad aggirare la linea delle imbarcazioni e a portarsi tra le stesse e la riva, pur rischiando di arenarsi. In tal modo colpì le navi sul lato più debole, che Brueys credeva al sicuro. I britannici in effetti bombardarono la flotta da entrambi i lati. La rapidità dell’attacco britannico colse i francesi di sorpresa: gran parte dei marinai erano ancora a riva e molti capitani erano a bordo de L’Orient, a conferire con Brueys. I capitani remarono verso le proprie navi, urlando ordini in modo disordinato in mezzo alla battaglia. La luna piena fu oscurata dal fumo proveniente dai cannoni e si face buio. L’unica luce proveniva dalle lanterne sui ponti e dal fuoco dei cannoni. Nelson fu ferito da una scheggia e un lembo di pelle cadde sull’occhio sano. Credette di morire, ma dopo le medicazioni tornò sul ponte e riprese il comando.
Una delle cannonate con cui fu colpita L’Orient tranciò di netto entrambe le gambe di Brueys, che piuttosto che andare sottocoperta, si fece legare su una poltrona in modo da poter continuare a dare ordini. Un altro colpo di cannone, però, lo colpì allo stomaco, quasi tagliandolo a metà. Quindici minuti dopo morì. Il capitano de L’Orient, Luc-Julien Casabianca, fu anch’egli ferito da diverse schegge e portato sottocoperta, lasciando suo figlio dodicenne Giaconte ad attendere in coperta.
Poco dopo, L’Orient si incendiò e fu chiaro a tutti che stava per esplodere. Diversi ufficiali e marinai si buttarono in mare. Il giovane Giaconte Casabianca, invece, preferì non abbandonare suo padre. All’incirca alle 22, la possente ammiraglia esplose con un botto fragoroso, illuminando la notte egiziana. Ogni nave vicina fu scossa dall’esplosione, che fu sentita dai soldati dell’esercito di Napoleone, a Rosetta, 32 km a est. Soldati, detriti in fiamme, parti del Tesoro maltese furono scaraventati in aria e ricaddero in mare. Pur essendoci qualche superstite, gran parte dei mille uomini de L’Orient perirono nell’esplosione.
Le ultime navi francesi ancora belligeranti si arresero pian piano, una dopo l’altra. All’alba del 2 agosto l’esito della battaglia non era più in questione. Il contrammiraglio Pierre-Charles Villeneuve, in commando della Guillaume Tell, dotata di 80 cannoni, ordinò la ritirata. Nella flotta francese, solo due navi e due fregate riuscirono a salvarsi, il resto dei vascelli fu distrutto o catturato. Due navi britanniche furono gravemente danneggiate, ma nessuna distrutta. Le perdite francesi andarono dai 2.000 ai 5000 uomini, i britannici persero “solo” 218 persone, con 677 feriti. “Il termine vittoria non è abbastanza per descrivere questa scena”, commentò Nelson alle prime luci dell’alba.
La vittoria britannica sui francesi fece fallire la spedizione napoleonica. L’esercito di 20.000 uomini fu intrappolato in Egitto senza nessuna linea di comunicazione verso Parigi, con il morale sotto i tacchi. Napoleone abbandonò i suoi uomini, tornò a Parigi senza preavviso l’agosto del ’99 e prese il potere il novembre dello stesso anno. Il generale che sostituì Bonaparte trovò un accordo con gli ottomani per una piena evacuazione delle truppe dall’Egitto, ma i suoi piani furono rovinati dai britannici, che non volevano che un esercito grande ed esperto tornasse a combattere su altri fronti.
Nel 1801 il parlamento britannico autorizzò una spedizione militare, che raggiunse Alessandria nel marzo dello stesso anno, per arrivare a una resa francese in Egitto. Con l’aiuto degli ottomani, in una manovra a tenaglia, gli inglesi strinsero i soldati francesi, che cedettero il Cairo a giugno e Alessandria ad agosto 1801. I soldati francesi si divisero su navi britanniche e ottomane e furono trasportati a casa disarmati. Quanto a Horatio Nelson, quando la notizia del trionfo della battaglia della Baia di Abukir raggiunse Londra il 2 ottobre, fu salutato con grandi celebrazioni ed entrò nella Camera dei Lord come Lord Nelson del Nilo. La battaglia rimane una delle più celebrate nella storia della British Navy.
LA STELE DI ROSETTA
La decifrazione dei geroglifici
La campagna d’Egitto di Napoleone non fu completamente disastrosa. Grazie a un soldato che fece una scoperta straordinaria, del tutto casualmente, contribuì in modo fondamentale agli studi sulla conoscenza dell’Antico Egitto.
Studiosi e appassionati potevano ammirare i geroglifici disseminati sui monumenti egizi, ma nessuno riusciva a capire cosa ci fosse scritto. Ormai da 15 secoli, il significato delle iscrizioni si era perso. L’antica civiltà (che andò dal 3200 al 342 a.C.) era avvolta dal mistero, perché nessuno riusciva a leggere quello che era stato scritto.
Nel 1799 un ufficiale francese stava sorvegliando il restauro del Forte di Rosetta, sulle rive del delta del Nilo. Accanto alle fondamenta del forte, durante gli scavi, fu colpita una pietra molto particolare, di basalto nero, alta poco più di un metro, larga circa 75 cm, dal peso di 762 kg, e portante diverse iscrizioni. La scoperta di quella che ora è nota come Stele di Rosetta segnò l’inizio dell’archeologia moderna, perché fornì la chiave per decifrare i geroglifici egizi.
La stele fu portata a Londra dopo la resa delle truppe napoleoniche nel 1801, come bottino di guerra. Entrò nella collezione del British Museum, dove si trova ancora adesso. Danneggiata e incompleta, riportava un decreto di un Consiglio di sacerdoti che si era riunito nella città di Menfi. Il Re Tolomeo V, Re di tutto l’Egitto, si unì al Consiglio. Tolomeo V era un re greco-macedone che governò sull’Egitto tra il 204 e il 108 a.C. Il decreto stabilì che il Re andava trattato come un Dio, perché aveva fatto molte cose buone per il suo Paese. Per ordine del Consiglio, il testo dell’editto doveva essere inciso sulla pietra ed esposto in tutti i più importanti templi egiziani. Il testo in sé è poco interessante. L’importanza invece fondamentale è che il testo fosse stato scritto in tre lingue. Le prime 14 righe sono geroglifici; seguono 32 righe in demotico e 54 righe in greco antico. Il demotico (così chiamato da Erotodo dal greco d?motikós, “popolare”) indica la fase della lingua scritta egiziana che va dal 700 circa a.C. sino alla fine dell’impero romano. Si tratta di uno sviluppo del cosiddetto neoegiziano, probabilmente un’evoluzione grafica dallo ieratico. Non era quasi mai utilizzato per testi sacri, letterari o iscrizioni funebri, ma (come dice il nome) era destinato al popolo. Quanto ai geroglifici, come detto, nessuno all’epoca della scoperta riusciva a decodificarne i segni.
Il II secolo a.C. fu un’era particolare in Egitto, quella della dinastia tolemaica, di origine greco-macedone, successiva al regno di Alessandro Magno, che governava da Alessandria. In quest’epoca, il greco e l’egiziano venivano entrambi parlati sulle rive del Nilo. Chi sapeva leggere e scrivere conosceva entrambe le lingue, probabilmente parlando l’egiziano a casa. Vi era quindi bilinguismo e multiculturalismo. Il fatto di considerare il faraone un dio non era tradizionale nella cultura egiziana fino ad allora. Si pensa perciò che il testo fu scritto in greco prima e tradotto nelle due lingue egiziane dopo. Una cultura di tipo ellenistico, quindi, imposta all’ Egitto tolemaico. Si trattava quindi dello stesso testo ripetuto tre volte, in tre tipi di scrittura diversi (due alfabeti e una lingua pittorica). Dato che il greco antico era una lingua conosciuta, occorreva mettere a confronto geroglifici e demotico con il greco. Numerose copie della stele vennero inviate in numerose università in tutta Europa, in modo che diversi studiosi potessero lavorarci contemporaneamente. Tra gli altri, il francese Jean-François Champollion e l’inglese Thomas Young.
Jean-François Champollion era un giovane e brillante linguista. Quando la pietra fu trovata, Champollion aveva solo nove anni, ma si narra che conoscesse già il latino, il greco e l’ebraico. Prima dei 20 anni, imparò altre sei lingue antiche orientali. Dopo mesi e mesi di studio e ricerca e di comparazione tra greco, demotico e geroglifici, il linguista cominciò a capire. Comprese che i segni venivano usati per i suoni oltre che per le parole. Una delle chiavi stava nel cerchio che racchiude i nomi dei re, detto cartiglio o cartouche.
Quanto ai nomi stranieri, fu scoperto che gli egiziani li scrivevano in modo fonetico: un suono corrispondeva a una lettera, in modo “alfabetico”. Riconoscendo quei nomi, grazie al testo greco corrispondente, si riuscì a costituire un “alfabeto” di una ventina abbondante di lettere, che permisero di leggere altre parti del testo. Le parti invece composte dai geroglifici furono più complicate da interpretare, non potendole leggerle alfabeticamente. Fu questo aspetto ibrido a complicare gli studi. Ci vollero infatti 22 anni per arrivare alla decifrazione dei geroglifici. Gli studiosi si servirono di altri oggetti, ma fu la stele di Rosetta a costituire il punto di partenza per svelarne il mistero. I risultati della ricerca furono condivisi tra gli studiosi, a partire dalle prime piccole traduzioni. Pur in anni di aspri conflitti tra Londra e Parigi, Champollion e Young si scrissero. Il francese si lamentò a più riprese di dover lavorare su copie scadenti della stele. Young lo aiutò, ricopiando parti del testo in una lettera. La relazione tra i due fu in parte competitiva, ma in parte collaborativa. Champollion fece passi da gigante nella decifrazione dopo aver imparato il copto (che lo aiutò a decifrare il demotico, di cui costituiva un’evoluzione) e, il 14 settembre 1822, annunciò di aver decifrato i geroglifici. Spiegò come ci era riuscito e quel che aveva scoperto nella pubblicazione “Lettre à M. Dacier”. Dacier era il “segretario perpetuo” dell’Académie Royale des inscriptions et belles-lettres di Parigi. Proprio nella capitale francese fu dato l’annuncio della scoperta, il 17 settembre del 1822.
Studiosi di tutto il mondo poterono cominciare a leggere le iscrizioni sui monumenti egiziani. Se la stele di Rosetta fu la chiave decisiva nell’interpretazione dei geroglifici, certamente la ricerca cominciata all’inizio del XIX secolo non era partita da zero. Per mille anni, studiosi arabi medievali e monaci copti cercarono di decifrare i segni che ricoprono i monumenti egiziani, riuscendo a carpirne i primi segreti. Uno degli aiuti di cui usufruì Champollion, per esempio, fu che il copto conteneva elementi del vecchio egiziano, riprodotto da geroglifici e demotico. Fu quello il motivo per il quale il linguista francese cominciò a impararlo, ricevendone grandi vantaggi nella sua ricerca. Allo stesso modo, il lavoro di Champollion non ha esaurito la ricerca in materia di geroglifici. Ma cosa sarebbe successo senza la campagna di Egitto di Napoleone? O se Napoleone non avesse portato con sé scienziati e archeologi? Non è possibile saperlo, ma forse oggi conosceremmo molto meno della storia della antica civiltà egizia e del suo fiume, il Nilo.
IL NILO
100 fatti e curiosità
100 fatti e curiosità sul Nilo
SEGNALAZIONI
“In principio era il fiume” è una serie di racconti sui principali fiumi del pianeta. Leggi la storia precedente:
Storie di Storia / 43. Storie sul Tamigi, il fiume più lungo d’Inghilterra
Libri:
Viaggio alle sorgenti del Nilo, di John Hanning Speke, Edizioni Theoria, ediz. 2022
Il libro descrive il viaggio dell’esploratore Speke, alla ricerca della sorgente del Nilo, nella metà del XIX secolo, insieme al suo compagno di viaggio Richard Burton. Il libro racconto dell’arrivo di Speke a Zanzibar, dove incontra Burton e con il quale inizia la spedizione. Il momento principale è la scoperta del Lago Vittoria, che Speke ritiene essere la fonte del Nilo. Si tratta di una delle spedizioni più preziose nella storia dell’esplorazione dell’Africa.
Assassinio sul Nilo, di Agatha Christie, Mondadori, 1944
Uno dei romanzi più famosi della scrittrice inglese Agatha Christie. Il detective belga Poirot è in vacanza ad Assuan, in attesa di imbarcarsi su una crociera sul Nilo quando la ricca ereditiera Linnet Doyle gli chiede di aiutarla. Qualche giorno dopo Linnet viene trovata morta. Tocca a Poirot scoprire l’assassino.
Dipinto: The Battle of the Nile, di Philip James de Loutherbourg, Tate Britain
Il quadro mostra il momento principale della Battaglia di Abukir, l’esplosione della nave francese L’Orient, alle 22 circa del 1° agosto 1798.
Musei:
The British Museum
Museo dalla collezione infinita. Oltre alla Stele di Rosetta, è presente una ricca collezione di architettura, mummie e altri oggetti provenienti dalle regioni del Nilo. Dal 2022 al 2023 è stata allestita la mostra “Hieroglyphs: Unlocking Ancient Egypt”.
Il Louvre
Il Département des Antiquités égyptiennes presenta una collezione ricchissima di statue, mummie, manufatti provenienti da tutta la regione del Nilo.
Film: Mystery Of The Nile, Diretto da Jodi Llompart, 2005
Film prodotto in IMAX che racconta della prima spedizione che è riuscita a navigare tutto il corso del Nilo Blu e del Nilo, dalla sorgente in Etiopia fino al Mediterraneo. Leader della spedizione il geologo Pasquale Scaturro. Il viaggio, compiuto in 114 giorni, è durato dal 22 dicembre 2003 al 28 aprile 2004.
Condividi questo contenuto: