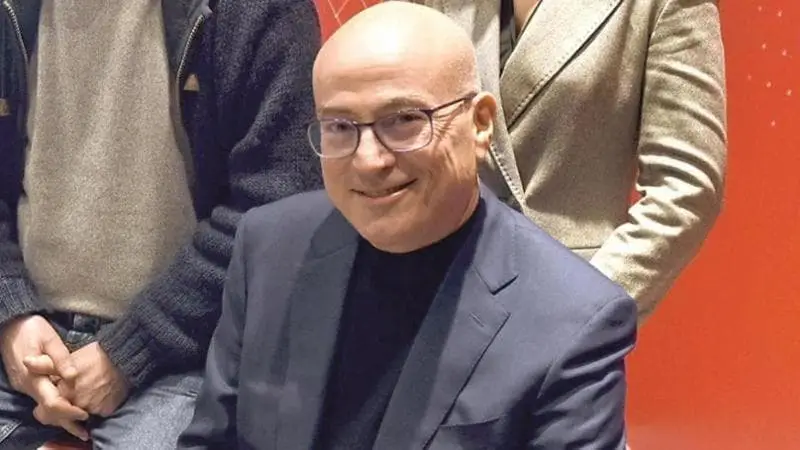La solitudine dei non amati, un inno alla libertà di amare e di amarsi. Un altro piccolo gioiello del fervente cinema norvegese
Sono anni importanti per il cinema norvegese. Il successo a Cannes di un regista come Joachim Trier – che nel 2021 con La persona peggiore del mondo ha visto la sua attrice prediletta, Renate Reinsve, ricevere il premio per la miglior interpretazione femminile e quest’anno con Sentimental Value ha vinto il Grand Prix della giuria – e il consenso raccolto dalla trilogia di Dag Johan Haugerud, Sex, Love e Dreams (con quest’ultimo vincitore del Leone d’oro a Berlino), ha fatto luce su una produzione diventa fra le più vive e complesse d’Europa.
Al fianco dei titoli più noti sono infatti emersi lavori altrettanto interessanti, come ad esempio La solitudine dei non amati (versione italiana dell’originale Elskling, cioè “amabile”), esordio nel lungo di Lilja Ingolfsdottir, regista con diversi corti alle spalle.
Vincitore nel 2024 del Premio Speciale della Giuria al Festival di Karlovy Vary, dov’era stato presentato in anteprima, il film racconta la vicenda sentimentale di Maria, una donna sulla quarantina che mentre il marito Sigmund è in viaggio si destreggia tra la carriera, la cura dei figli e la gestione della casa.

In realtà, il vero problema della donna è che anche questo suo secondo matrimonio è sull’orlo della fine e che Sigmund, incontro e amato subito dopo la prima separazione, con il tempo è diventato un’abitudine, se non un peso, nella sua vita.
Maria sfrutta però la delusione data da un nuovo fallimento come un’occasione per riflettere sulla sua vita e così capire l’origine della sua apparente incapacità di amare e farsi amare.
Sebbene, dunque, sembri un classico dramma sul divorzio, La solitudine dei non amati esce dal luogo comune del ritratto di donna in difficoltà (ci sono esempi straordinari nella storia del cinema, e sembrerebbe che Una donna tutta sola di Mazursky resti un modello anche inconsapevole) per entrare nei territori meno esplorati di una crisi d’autostima.
Maria non indugia nel complesso della vittima e non si sofferma sulle responsabilità del marito, ma si chiede quali siano i limiti dei suoi desideri facendo così del film uno strano studio di carattere.
La regista, anche sceneggiatrice, è abile nel trasformare la sua protagonista (interpretata da Helga Guren) in un modello di donna contemporanea, indipendente e fragile, con un’idea di romanticismo messa in discussione dai rovesci della vita e una femminilità che ancora si scontra con le richieste di un’intera società, e non solo di un uomo che, pure lui, pretende di amare e di essere amato.
L’ironia contenuta nel titolo del film, con la parola “amabile” assunta a simbolo di tutto ciò che la protagonista non sa a essere, offre quindi la chiave per leggere il film: un percorso di conoscenza di sé che non prevede per forza di cose l’adesione a modelli di condivisi e condivisibili, ma il ritratto della donna “meno amabile del mondo”, e magari per questo anche la più libera.
Condividi questo contenuto: