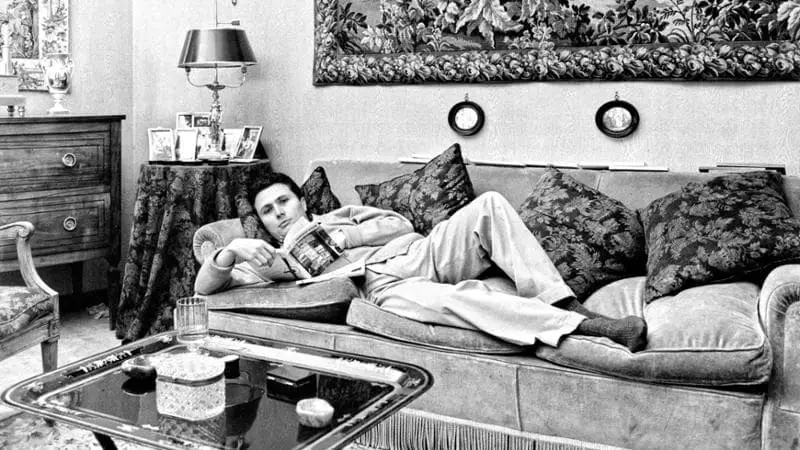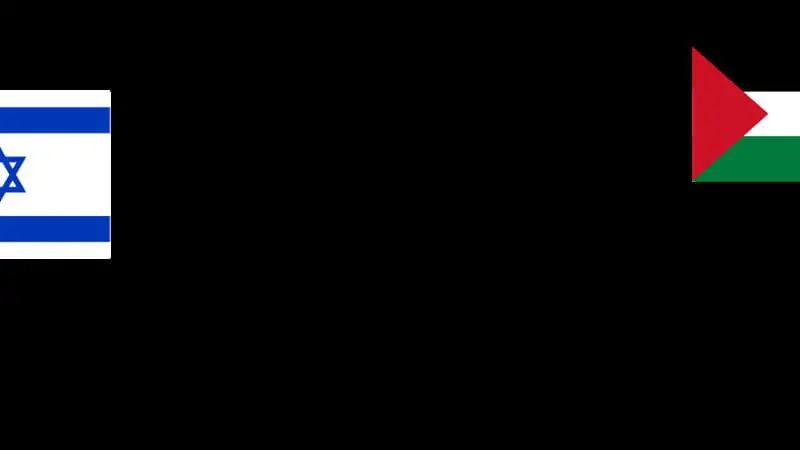Storie di storia / 90. Tre storie sul Reno
Nilo, Yangtse, Tigri, Eufrate, Tevere: fin da piccoli, maestri elementari e sussidiari ci hanno insegnato che non esistono grandi civiltà senza un fiume. Sorgente di acqua potabile o fonte per l’irrigazione dei campi, il fiume costituisce spesso anche un mezzo di trasporto essenziale per i commerci o una via di accesso al mare. Vedute straordinarie ritratte da artisti e ponti leggendari raccontati da poeti rappresentano specchi che riflettono millenni di storia. Questi racconti, dedicati al Reno, proseguono una serie di storie legate ai grandi fiumi del mondo. Buona lettura!
LA STORIA
IN PRINCIPIO ERA IL FIUME
Tre storie sul Reno
Di Davide De Leo (Linguista, PhD)
Il Reno è uno dei principali corsi d’acqua d’Europa, da sempre al centro della geopolitica del Vecchio continente. Importante via di comunicazione, attraversa città storiche come Basilea, Colonia e Rotterdam e un’ex capitale. Ha grande rilevanza culturale e strategica, oltre a essere associato a numerose leggende e opere artistiche. Il suo bacino idrografico è uno dei più densamente popolati e industrializzati d’Europa, ma anche ricco di paesaggi suggestivi.
Qui di seguito sono raccontate tre storie legate al Reno. Successivamente, 100 fatti e curiosità sul fiume.
IL RENO COME VIA D’ACQUA INTERNAZIONALE
Il Trattato di Vienna del 1815 e la riorganizzazione europea
Nel contesto della ridefinizione politica dell’Europa post-napoleonica, il Congresso di Vienna (1814-1815) segnò un punto di svolta non soltanto per gli equilibri geopolitici continentali, ma anche per la gestione e l’uso delle grandi vie fluviali internazionali, tra le quali il Reno. Tradizionalmente percepito come confine strategico e linea di demarcazione culturale tra l’Europa latina e quella germanica, il Reno assunse, con il Trattato di Vienna, un nuovo ruolo: quello di arteria commerciale sovranazionale, soggetta a un regime giuridico internazionale che ne garantisse l’accesso e la navigazione libera.
Questa trasformazione fu tutt’altro che accidentale. Durante l’epoca napoleonica, il controllo sul Reno aveva assunto una dimensione centrale nella strategia militare e amministrativa della Francia. L’annessione della riva sinistra e la sua organizzazione in dipartimenti francesi avevano reso il fiume un asse interno alla macchina imperiale, funzionale tanto al movimento delle truppe quanto alla circolazione di merci. Con la caduta di Napoleone, tuttavia, i partecipanti al Congresso si trovarono a dover risolvere il nodo non solo della sovranità territoriale lungo il bacino renano, ma anche del regime giuridico e commerciale cui il fiume stesso sarebbe stato sottoposto. Era evidente che il Reno non poteva più essere concepito come proprietà esclusiva di un solo Stato. La sua estensione, dalla sorgente nelle Alpi svizzere fino alla foce nel Mare del Nord nei Paesi Bassi, lo rendeva inevitabilmente una risorsa interstatale.
La soluzione adottata dal Congresso di Vienna fu innovativa: il Reno fu dichiarato “via navigabile internazionale”, sottoposta a un regime multilaterale che ne potesse assicurare la libertà di commercio e di circolazione per tutte le nazioni rivierasche. L’articolo 108 dell’Atto finale del Congresso stabiliva che “la navigazione dei fiumi principali, che attraversano più di uno Stato, deve restare interamente libera, dal punto in cui diventano navigabili fino alla loro foce”. Questo principio, all’epoca senza precedenti a livello europeo, sanciva un primo tentativo di superamento delle sovranità assolute in favore di una gestione cooperativa di una risorsa naturale e infrastrutturale.
Tale decisione si inseriva all’interno di un più ampio progetto di stabilizzazione e “razionalizzazione” dell’Europa post-bellica. Dopo due decenni di guerre rivoluzionarie e imperiali, le potenze vincitrici — Gran Bretagna, Russia, Prussia e Austria — puntavano a creare un sistema di equilibrio duraturo, non solo mediante la restaurazione dei monarchi legittimi o la ridistribuzione dei territori, ma anche attraverso la creazione di istituzioni permanenti capaci di mediare conflitti potenziali e di armonizzare gli interessi divergenti. La questione del Reno fu, in questo senso, paradigmatica: pur essendo un problema apparentemente tecnico — concernente il diritto di passaggio, i dazi doganali, la manutenzione delle vie fluviali —, esso nascondeva un nodo politico fondamentale, ovvero quello del controllo economico dei territori centrali d’Europa e della possibilità di accesso al commercio continentale da parte delle nuove potenze emergenti.
In pratica, la realizzazione di questo progetto giuridico si concretizzò nella creazione della Commissione Centrale per la Navigazione del Reno (CCNR), istituita ufficialmente nel 1815, ma operativa dal 1816. Con sede prima a Magonza e successivamente a Strasburgo, essa è oggi la più antica organizzazione internazionale ancora attiva. La Commissione fu incaricata di garantire la libertà della navigazione lungo il Reno, regolando il traffico fluviale, uniformando le norme tecniche, sopprimendo i dazi interni, vigilando sulle opere di manutenzione idraulica e facilitando gli scambi commerciali. Anche se inizialmente i suoi poteri erano limitati e fortemente influenzati dalle monarchie dell’epoca, l’esistenza stessa di una tale istituzione segnava una svolta profonda nell’approccio europeo alla cooperazione transfrontaliera.
Dal punto di vista economico, la liberalizzazione del traffico sul Reno riuscì a dare un efficace impulso allo sviluppo dei commerci nel cuore dell’Europa continentale. Le città fluviali — da Basilea a Colonia, da Magonza a Duisburg — conobbero una rapida espansione, favorita dall’intensificazione dei traffici e dall’integrazione dei mercati regionali. Le infrastrutture fluviali, già parzialmente modernizzate durante il periodo napoleonico, furono ulteriormente migliorate nel corso del XIX secolo, con la canalizzazione di tratti difficili, la costruzione di argini, la regolazione delle portate stagionali e, in seguito, l’introduzione della navigazione a vapore. Tutto ciò contribuì a fare del Reno non solo una via di comunicazione efficiente, ma anche un asse strategico per l’industrializzazione nascente.
In questo senso, il Reno svolse una funzione duplice: da un lato, fu protagonista della “rivoluzione industriale continentale”, facilitando il trasporto di carbone, acciaio, cereali, legname e altri beni fondamentali per le economie in trasformazione; dall’altro lato, fu un vettore di circolazione delle idee, delle persone, delle tecnologie e delle istituzioni. Non è un caso che molte delle innovazioni tecnologiche in ambito idraulico, ingegneristico e amministrativo sviluppate lungo il Reno vennero successivamente esportate e imitate in altri contesti europei, come il Danubio, il Rodano o il Po.
Dal punto di vista politico, la gestione internazionale del Reno si rivelò anche un banco di prova importante per le relazioni diplomatiche tra gli Stati europei. Sebbene nel corso del XIX secolo non mancarono momenti di tensione — si pensi, ad esempio, al ruolo strategico del Reno nelle guerre franco-prussiane, o alle rivendicazioni francesi sulla “frontiera naturale” del Reno — la presenza di una cornice giuridica e istituzionale condivisa contribuì a mantenere il conflitto entro certi limiti e ad aprire canali di comunicazione anche nei momenti più difficili. In questo senso, la storia del Reno rappresenta uno degli esempi più longevi e significativi di diplomazia fluviale, ovvero di quel tipo di diplomazia che si sviluppa non attorno a confini da difendere, ma a risorse comuni da gestire.
La trasformazione del Reno da frontiera politico-militare a via d’acqua internazionale regolata da un regime multilaterale fu una delle eredità più durature del Congresso di Vienna. Essa anticipò, in molti aspetti, i principi della cooperazione internazionale moderna, basata sul diritto condiviso, sulla gestione integrata delle risorse, sulla costruzione di istituzioni sovranazionali capaci di mediare e coordinare gli interessi degli Stati. Al tempo stesso, confermò il ruolo centrale del Reno nello spazio europeo: non più solo linea di separazione, ma arteria di unificazione economica, politica e simbolica, destinata a rimanere tale fino ai nostri giorni.
Bonn capitale della Repubblica Federale di Germania: storia, ruolo e trasformazione(1949–1990)
Bonn, oggi tranquilla città sulle rive del Reno nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, ha origini antichissime. Fondata dai Romani come Bonna, è sempre stata un centro di rilievo secondario rispetto ad altre città tedesche più grandi. Nel XVIII secolo fu sede dell’Elettorato di Colonia e residenza principesca degli elettori coloniensi, ma dopo l’occupazione napoleonica perse il suo status di capitale territoriale. Durante il XIX e XX secolo, Bonn si sviluppò come centro universitario (grazie alla prestigiosa università fondata nel 1818) e come cittadina borghese e culturale, con importanza politica limitata.
Tuttavia, fu proprio questa relativa marginalità – unita alla sua posizione geografica favorevole e alla simbologia culturale e politica – a favorire la scelta di Bonn come sede provvisoria del governo della Germania Ovest nel 1949, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’avvio della divisione della Germania.
La fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 aveva lasciato la Germania distrutta, occupata e divisa in zone controllate dalle potenze alleate. Berlino, l’antica capitale imperiale e poi nazista, si trovava interamente dentro la zona di occupazione sovietica, rendendo problematica ogni prospettiva di farne la sede di un nuovo governo democratico occidentale. Con l’acuirsi della guerra fredda e la rottura politica tra URSS e potenze occidentali, i territori occidentali della Germania intrapresero un percorso separato: nacque così la Repubblica Federale di Germania (RFG) nel maggio 1949.
La questione della capitale del nuovo stato federale fu immediatamente dibattuta. Diverse città si candidarono: Francoforte sul Meno era favorita per centralità economica e infrastrutture, mentre altre proposte includevano Kassel, Stoccarda e la stessa Berlino Ovest (che però, come ricordato, era geopoliticamente isolata e non pienamente sotto il controllo occidentale).
Fu Konrad Adenauer, leader della CDU e futuro primo cancelliere federale, a proporre e sostenere Bonn. Adenauer era nato a Colonia, città vicina, e conosceva bene Bonn; la vedeva come una scelta simbolica e politica. Scegliere Bonn, piccola città universitaria e priva di potere industriale o finanziario, significava evitare un eccessivo centralismo e garantire una capitale temporanea, coerente con il principio che la Repubblica Federale fosse solo una parte della Germania in attesa di riunificazione. La scelta cadde su Bonn il 3 novembre 1949, dopo un acceso voto parlamentare: vinse di poco contro Francoforte.
Una volta scelta, Bonn si trasformò rapidamente da cittadina provinciale a centro politico della nuova Germania Ovest. In pochi anni furono costruiti ministeri, sedi parlamentari, residenze ufficiali e infrastrutture amministrative. Il Bundestag (parlamento federale) si riunì nel vecchio Museo d’arte Kammerspiele, poi trasformato nel Bundeshaus, sede della vita politica tedesca fino al 1999.
Il governo federale, sebbene decentrato secondo i principi del federalismo tedesco, concentrava a Bonn i ministeri chiave, l’ufficio del cancelliere e del presidente federale, la Corte costituzionale (anche se con sede decentrata a Karlsruhe) e le rappresentanze diplomatiche.
La città fu trasformata con nuove infrastrutture: vennero potenziati trasporti, comunicazioni, alloggi governativi, scuole internazionali. Tuttavia, per mantenere la natura “provvisoria” della capitale, venne imposto un limite alla monumentalità degli edifici pubblici. A differenza di Berlino, Bonn non ebbe mai un’architettura da “capitale imperiale”, e questo fu deliberato: l’obiettivo era evitare ogni ritorno al centralismo autoritario e alla simbologia del passato nazionalsocialista.
Nonostante ciò, Bonn divenne un centro politico pienamente operativo e persino strategico. Dal 1951, le ambasciate dei Paesi alleati vennero stabilite in città. Il ruolo internazionale della Germania Ovest – pur inizialmente limitato – crebbe nel tempo, specialmente dopo il Trattato dell’Eliseo (1963) tra Adenauer e De Gaulle e l’ingresso nella NATO (1955) e nella CEE (1957).
Nel corso dei decenni, Bonn divenne non solo sede di governo, ma anche simbolo dell’identità democratica e moderata della Repubblica Federale. In contrasto con l’immagine grandiosa e militarista del passato tedesco, Bonn rappresentava una Germania ridimensionata, occidentale, atlantica, federalista e pacificata.
Questo si rifletteva nel tono stesso della vita politica: la città non fu mai una metropoli, e proprio questa sua dimensione “umana” fu considerata un vantaggio. Deputati, ministri e funzionari potevano vivere in maniera informale, muoversi a piedi o in bicicletta, frequentare caffè e trattorie. La stampa anglofona descriveva Bonn come una “capitale villaggio” (village capital), con un’atmosfera quasi idilliaca rispetto alle capitali caotiche del mondo.
Inoltre, Bonn acquisì una valenza culturale e simbolica. Ospitava la sede della Deutsche Welle (radio e televisione internazionale tedesca), fondazioni politiche, archivi storici, e istituzioni accademiche. L’Università di Bonn, frequentata da molti figli della classe politica e diplomatica, accrebbe il suo prestigio.
La capitale fu anche teatro di momenti critici: la crisi degli anni ’60, le proteste studentesche del ’68, l’azione terroristica della RAF (Rote Armee Fraktion), la Ostpolitik di Willy Brandt. Bonn fu lo scenario dove si decisero le tappe della normalizzazione della Germania Ovest come stato democratico, membro leale della NATO e della Comunità europea.
L’unificazione della Germania nel 1990, dopo la caduta del Muro di Berlino (1989), cambiò radicalmente lo status di Bonn. Fin dalla fondazione della RFG, la sua costituzione aveva sempre indicato che la sede del governo era “provvisoria”. Ora, con Berlino nuovamente capitale della Germania unificata, si poneva la questione del trasferimento.
Il Bundestag votò nel 1991, dopo un acceso dibattito, a favore del ritorno della capitale a Berlino. La decisione non fu immediata: richiese anni di transizione (1991–1999). Molti ministeri furono trasferiti solo progressivamente, alcuni rimasero a Bonn in forma di “sedi secondarie”.
Per compensare la perdita del ruolo di capitale, la città ricevette un riconoscimento speciale: fu designata “Bundesstadt” (Città federale). Inoltre, vennero mantenute alcune funzioni istituzionali e vennero trasferite a Bonn diverse agenzie e uffici delle Nazioni Unite, come la sede tedesca dell’UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici). Anche la Deutsche Welle e il servizio meteorologico tedesco rimasero a Bonn.
Nel XXI secolo, Bonn ha saputo reinventarsi. Pur avendo perso il ruolo di capitale politica, è diventata un centro amministrativo, accademico, ambientale e culturale. È oggi un punto di riferimento per la cooperazione internazionale su ambiente, sviluppo e clima.
La città promuove attivamente la sua “eredità di capitale”, con musei come la Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, che raccontano la storia della Germania dal 1945 a oggi. Il Bundestag ha mantenuto una piccola rappresentanza in città e molti ex edifici governativi sono stati riconvertiti in sedi universitarie o conferenze.
Bonn è oggi una capitale morale e simbolica di un’epoca importante della Germania: quella della rinascita democratica, della stabilità postbellica, dell’integrazione europea e del superamento del nazionalismo. La sua trasformazione da capitale provvisoria a “capitale sostenibile” rappresenta una traiettoria unica tra le città europee del secondo Novecento.
La storia di Bonn come capitale della Repubblica Federale di Germania (1949–1990) è un esempio raro di come una città secondaria sia stata chiamata a un ruolo centrale in un momento cruciale della storia europea. Simbolo di moderazione e provvisorietà, Bonn ha incarnato i valori democratici e federali della nuova Germania post-nazista. La sua capacità di adattamento, dopo la riunificazione, ne fa oggi un modello di città post-capitale: consapevole del proprio passato, attiva nel presente, proiettata verso il futuro.
L’inquinamento del Reno: storia, dinamiche e prospettive ambientali
Nell’arco della sua storia recente, soprattutto a partire dalla Rivoluzione industriale, il Reno ha subito un deterioramento ambientale di notevole portata, diventando a più riprese uno dei fiumi più inquinati d’Europa. Tale processo, generato da una molteplicità di fattori legati alla pressione antropica, ha avuto impatti profondi sull’ecosistema fluviale, sulla salute pubblica e sulla fruizione economica e sociale del fiume. Parallelamente, dalla seconda metà del Novecento, si è sviluppata una complessa rete di iniziative istituzionali, normative e scientifiche orientate al risanamento e alla protezione del bacino idrografico renano.
Le origini dell’inquinamento del Reno si radicano nella trasformazione industriale che ha interessato l’Europa centro-occidentale tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Il corso medio e basso del fiume, in particolare le regioni industriali della Ruhr e della Renania, ha subito una rapida urbanizzazione e un’intensificazione dell’attività mineraria, siderurgica e chimica, spesso in assenza di normative ambientali o sistemi di trattamento degli scarichi. Fino agli anni ’60 del Novecento, l’intero sistema fluviale veniva utilizzato come canale di smaltimento di reflui industriali e urbani, con il risultato che le acque del Reno registravano livelli elevatissimi di metalli pesanti, sostanze organiche biodegradabili, idrocarburi, solventi e pesticidi.
La qualità dell’acqua subì un tracollo visibile anche a livello macroscopico: l’ossigeno disciolto diminuì al punto da rendere alcune sezioni del fiume praticamente prive di vita acquatica, mentre la flora e la fauna tipiche dei fiumi temperati andarono incontro a un drastico declino. Il fiume era frequentemente caratterizzato da odori nauseanti, acque torbide, fioriture algali e morie ittiche. Gli impatti non si limitavano alla sfera ecologica: la potabilità dell’acqua, la sicurezza alimentare legata alla pesca e l’uso ricreativo delle sponde venivano compromessi in modo sistematico.
Un punto di svolta nella percezione pubblica e politica dell’inquinamento del Reno si ebbe nel 1986, quando un grave incidente industriale presso uno stabilimento della Sandoz, nei pressi di Basilea, determinò il rilascio accidentale nel fiume di oltre 30 tonnellate di sostanze chimiche tossiche, incluse grandi quantità di pesticidi, mercurio e altri composti organici. Le acque del Reno si tinsero di rosso per giorni, milioni di pesci e invertebrati morirono e il disastro fu percepito come uno degli eventi ambientali più gravi in Europa nella seconda metà del secolo. L’incidente di Schweizerhalle agì da catalizzatore, accelerando un processo di riforma ambientale già in atto, ma ancora frammentario.
Già dal 1950, i Paesi bagnati dal Reno avevano dato vita alla Commissione Internazionale per la Protezione del Reno (ICPR), con l’obiettivo di coordinare gli sforzi di monitoraggio e riduzione dell’inquinamento. Tuttavia, fu solo a partire dagli anni Settanta che iniziò una pianificazione ambientale più sistematica. I governi della regione renana investirono ingenti risorse nella costruzione e modernizzazione degli impianti di depurazione, nello sviluppo di sistemi di monitoraggio chimico e biologico, e nella regolamentazione degli scarichi industriali, imponendo limiti alle concentrazioni di sostanze prioritarie.
Un risultato tangibile di tali interventi fu la riduzione dei carichi inquinanti in molte sezioni del fiume. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila, le concentrazioni di metalli pesanti come mercurio, cadmio e piombo diminuirono sensibilmente, grazie anche alla chiusura o riconversione di molti impianti industriali ad alto impatto. Parallelamente, si assistette al ritorno di alcune specie ittiche sensibili, tra cui il salmone atlantico, oggetto di programmi specifici di reintroduzione e facilitazione della migrazione, come i progetti “Salmon 2000” e “Salmon 2020”. In alcune aree, la qualità biologica delle acque migliorò al punto da permettere attività ricreative e pesca controllata, anche se spesso in forma limitata e localizzata.
La questione dell’inquinamento del Reno, tuttavia, non può essere considerata risolta. Nonostante i miglioramenti registrati in termini di concentrazioni di inquinanti “classici”, permangono diverse criticità, a partire dalla presenza diffusa e crescente di microplastiche. Studi recenti hanno rilevato che il Reno presenta una delle più alte densità di microplastiche tra i fiumi europei, soprattutto nelle zone urbane e industrializzate. Queste particelle, oltre a costituire un rischio diretto per gli organismi acquatici che le ingeriscono, fungono da vettori per altri contaminanti, contribuendo al bioaccumulo e alla diffusione di sostanze tossiche lungo la catena alimentare.
Altri contaminanti emergenti includono i residui farmaceutici, gli interferenti endocrini, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e i sottoprodotti della disinfezione, la cui presenza è ancora poco regolamentata ma potenzialmente nociva per l’ecosistema e per la salute umana. La complessità di queste nuove minacce richiede l’adozione di tecniche di depurazione avanzata, oltre che un aggiornamento continuo delle normative e dei protocolli di controllo.
Un ulteriore elemento di pressione ambientale è rappresentato dal cambiamento climatico. L’innalzamento delle temperature medie e la modifica del regime delle precipitazioni hanno già determinato effetti misurabili sul Reno. Nei periodi estivi, la portata fluviale si riduce, provocando un aumento della concentrazione di inquinanti e una diminuzione dell’ossigeno disciolto, con effetti negativi sulla fauna acquatica. Gli eventi di piena, sempre più intensi e frequenti, possono invece mobilitare sedimenti contaminati e diffondere inquinanti che si trovano da decenni nei fondali. Inoltre, l’aumento delle temperature delle acque favorisce la proliferazione di alghe tossiche e la diffusione di specie invasive a scapito della biodiversità autoctona.
Le risposte possibili a questi nuovi scenari si articolano su più livelli. Dal punto di vista tecnico, è fondamentale continuare a investire in tecnologie di trattamento avanzato delle acque reflue, capaci di rimuovere non solo i nutrienti e le sostanze organiche, ma anche i contaminanti emergenti. Dal punto di vista istituzionale, si rende necessario un rafforzamento della cooperazione transnazionale, in particolare nella gestione integrata del bacino idrografico, che coinvolga autorità locali, agenzie ambientali, mondo accademico e società civile. Infine, dal punto di vista ecologico, occorre promuovere interventi di rinaturalizzazione del fiume, attraverso la ricostituzione delle aree golenali, la riapertura delle pianure alluvionali, la rimozione di barriere alla migrazione degli organismi e il ripristino della vegetazione ripariale.
Il Reno, da fiume “morto” a risorsa recuperata, costituisce una lezione di resilienza ambientale, ma anche un monito sulle responsabilità collettive nella gestione sostenibile dei beni comuni.
IL RENO
100 fatti e curiosità
100 fatti e curiosità sul Reno
SEGNALAZIONI
Poesia:
La Lorelei, di Heinrich Heine, 1824
La poesia è una delle opere letterarie più famose associate al Reno. Lorelei, una seducente e fatale sirena del fiume Reno ipnotizza i marinai con il suo canto, facendoli schiantare contro gli scogli.
La poesia è diventata un mito centrale nella letteratura tedesca e ha ispirato numerosi adattamenti musicali, in particolare la canzone di Heinrich Heine del 1837 e il poema sinfonico di Franz Liszt (entrambi chiamati Lorelei).
Opera:
L’oro del Reno, di Richard Wagner, 1854
Prima del ciclo di quattro opere di Wagner dette L’anello del Nibelungo, L’oro del Reno è ambientato in parte nelle profondità del fiume e narra di un tesoro magico. I temi esplorati dall’opera sono il potere, l’avidità e il sovrannaturale. L’opera ha avuto un’influenza profonda sulla musica classica occidentale e ha un ruolo centrale nell’impronta culturale renana.
Pittura:
Viaggio sul Reno, di Joseph Mallord William Turner, anni 1830
Il pittore romantico inglese Turner creò una serie di 51 dipinti a olio del Reno, rappresentandone la maestosa bellezza e il misticismo. Tra i più famosi della serie, Il Reno a Colonia e Le cascate di Sciaffusa.
Il Romanticismo renano, fine XVIII-inizio XIX
Il Reno divenne un soggetto così centrale per i pittori romantici in questo periodo che si creò un movimento detto Romanticismo renano. Pittori come Carl Gustav Carus erano attratti dal mistero del fiume e ne rappresentarono scenari, castelli medievali e leggende. Il movimento contribuì a far conoscere la bellezza naturale e i temi storici e mitologici renani.
Il Reno a Duisburg, di Paul Klee, 1937, esposto a The Metropolitan Museum of Art, New York
Opera vibrante con forme geometriche e colori forti, per un’atmosfera insieme onirica e contemplativa. Con le tinte blu, verdi e gialle Klee rappresenta il fiume, mentre le linee sinuose evocano il movimento dell’acqua. Natura e astrazione si incontrano, per un’esperienza visiva unica.
“In principio era il fiume” è una serie di racconti sui principali fiumi del pianeta. Leggi le storie precedenti:
Storie di Storia / 43. Storie sul Tamigi, il fiume più lungo d’Inghilterra
Storie di storia / 88. Tre storie sul Nilo
Condividi questo contenuto: