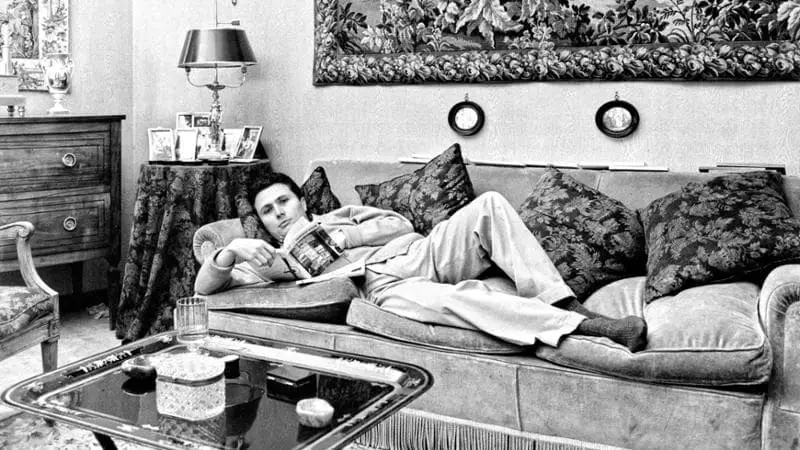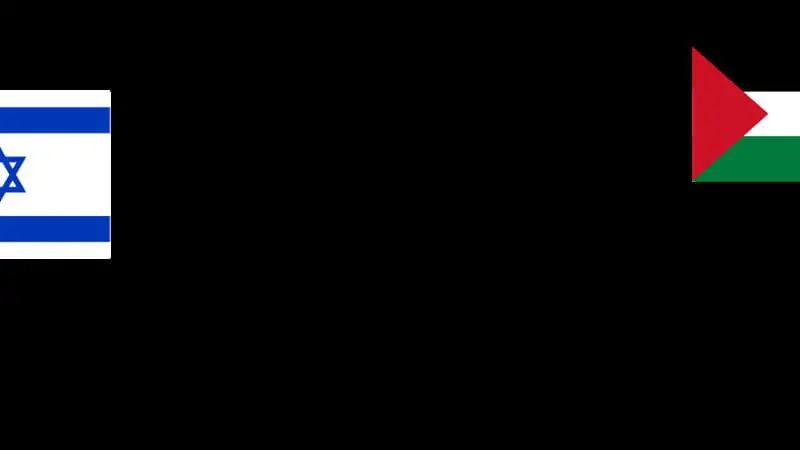13 e 17, che paura. Perché temiamo quei numeri tabù
Aggiungi un posto a tavola o c’è una sfiga in più. Potrebbe essere lo slogan dei soggetti affetti da triscaidecafobia, una parola di origine greca che sembra uno scioglilingua ed è composta da tris (tre) più deca (dieci) che fa tredici. La inventò ai primi del Novecento lo psicanalista americano Isador Coriat per definire la paura superstiziosa del numero 13, paura che in realtà esiste da molto prima che la medicina le desse un nome. Probabilmente la fama sinistra che circonda questa cifra nasce proprio dal ricordo dell’Ultima Cena, dove i commensali erano tredici, Cristo più gli apostoli.
E vista la drammatica conclusione della serata non è difficile che la tradizione popolare se la sia legata al dito facendone un presagio di sventura. Ecco perché si crede che mettersi in tredici a tavola costerà la vita ad uno dei convitati. Anche l’antica mitologia germanica ha il suo Cenacolo. È il banchetto del Walhalla, l’Olimpo nordico, dove l’arrivo di Loki, il tredicesimo e sgraditissimo ospite, dà inizio a una serie di sventure che porteranno al Ragnar?k, il crepuscolo degli dei. Ma la cattiva fama che grava sul numero incriminato viene da tempi ancor più lontani. Una leggenda vuole che Filippo il Macedone, padre di Alessandro Magno, si fece erigere una statua mentre era ancora in vita e la fece aggiungere a quelle delle dodici divinità più venerate. La legge del tredici scattò inesorabile e il sovrano finì assassinato, anche lui a tavola.
L’ultima cena di Juan de Juanes (Museo del Prado, Madrid. Photo by Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)
L’ombra nefasta del numero si allunga fino ai nostri giorni. E non risparmia nemmeno il mondo del business. Non a caso molte compagnie aeree non hanno la fila 13 a bordo dei loro velivoli. Una misura scaramantica? O più semplicemente rispettosa dei diritti dei superstiziosi. Che sono una maggioranza silenziosa, ma capace di far valere le sue ragioni. Risultato, in molte metropoli i grattacieli non hanno il tredicesimo piano o, meglio, lo hanno ma truccato da 12 bis. E alla Otis Elevator Company, leader mondiale del trasporto verticale, hanno più volte dichiarato che la maggior parte delle pulsantiere dei loro ascensori non ha un “piano chiamato 13”. Lo stesso dicasi degli alberghi, dove si passa direttamente dalla camera 12 alla 14 o si ricorre all’escamotage del 12 bis. In fondo la triscaidecafobia è un tentativo di tradurre delle coincidenze negative in una regola. Un’aritmetica del mistero che dà l’illusione di prevedere l’imprevedibile e calcolare l’incalcolabile. Questa sorta di corrispondenza cabalistica tra numeri ed eventi, che rappresenta la cifra nel tappeto della vita, non poteva non ispirare quelle industrie contemporanee del mito e della fiaba che sono l’horror e il fantasy. Un esempio per tutti, il racconto Room 1408 di Stephen King, che ha come protagonista la stanza di un albergo di New York che non viene più affittata perché in passato tutti i suoi ospiti si sono suicidati o morti in circostanze misteriose, ma le loro ombre continuano ad infestarla. Le cifre sommate della camera fanno giusto tredici. Perché stupirsi, allora, se non se ne esce vivi!
Non abbiate più paura del gatto nero
Nel mondo anglosassone sul 13 ci hanno messo una croce sopra. Al punto che nella stragrande maggioranza dei ristoranti, dai fish and chips agli stellati, il tavolo portasfiga è tabù. Il direttore dell’esclusivissimo Le Gavroche, uno dei santuari della gastronomia londinese e il preferito di Lady Diana, fondato dai masterchef francesi Michel e Albert Roux, ha raccontato che quando i vip riservavano un tavolo non volevano nemmeno sentir nominare il 13. E considerato che in qualche caso il conto era di ventimila euro a testa – però vini e sigari inclusi – era ovvio che i clienti non volessero essere neanche minimamente turbati da pensieri negativi. Nonostante la scaramanzia, il ristorante ha chiuso i battenti nel 2023 e ha messo all’asta la sua cantina con bottiglie da dodicimila euro. Colpa del numero sfortunato o del costo smisurato? Chi può dirlo! Comunque, in certi casi viene da pensare che davvero “la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”. Il copyright è di Freak Antoni, mitico leader degli Skiantos. Ed è difficile dargli torto.
Benedette corna, coppia regina degli scongiuri
Se gli anglosassoni temono il 13 come la peste, noi mediterranei invece soffriamo di eptacaidecafobia, la paura del 17. Esemplare il caso del teatro di San Carlo, tempio napoletano della lirica, dove la direttrice Emmanuela Spedaliere è stata costretta a rinumerare il palco 17 con il 16bis, perché nonostante la posizione favolosa accanto al palco reale, nessuno lo voleva. La cattiva aura che circonda il 17 risale probabilmente alla Roma antica dove la cifra, scritta in numero romano XVII, anagrammandola diventava VIXI, cioè vissi. Come dire fui, ora non più. E ho detto tutto. Se poi il diciassette del mese capita di venerdì, allora bisogna toccarsi, munirsi di cornetti e affidarsi al proprio santo protettore. Perché il calendario ci sta lanciando un doppio S.O.S. La trista nomea del venerdì era tale che a partire dal Medioevo la credenza popolare collocava di venerdì tutti gli eventi luttuosi la cui data era incerta.
Razionali si nasce, superstiziosi alla fine si diventa
La cacciata di Eva e Adamo dall’Eden, l’episodio di Caino e Abele, la decollazione di San Giovanni Battista, la Strage degli innocenti. E soprattutto il giorno della morte di Cristo. «De la crudel morte de Cristo, ogn’om pianga amaramente», recita il versetto antisatanico del Laudario di Cortona, un codice musicale duecentesco conservato nella biblioteca della cittadina toscana; suona come un anatema la cui eco continua a risuonare nel nostro immaginario. Certo è che il venerdì nell’Italia tradizionale era out. Non ci si sposava, non si mangiava carne, non si debuttava con uno spettacolo, non si chiamava il medico, non si faceva il pane né il bucato, non ci si scambiavano visite né regali, non si piantavano ortaggi né legumi, non si cuciva né si rammendava. E, ciliegina sulla torta, si credeva che i nati di venerdì fossero destinati ad una vita triste, a praticare la stregoneria e perfino a trasformarsi in lupi mannari.
Pitagora, padre della numerologia, considerava molesto il 17 perché si insinuava come un sabotatore tra due numeri perfetti come il 16 e il 18. Un attentato all’armonia del mondo. Se poi l’attentato avviene di venerdì, allora meglio aspettare che passi la nottata. E il giorno dopo consolarsi con Pino Daniele: «oggi è sabato… meno male».
La serie – Prosegue “Non è vero ma ci credo” di Marino Niola. La serie a puntate attraverso la quale l’antropologo ci guida alla scoperta di quanto resta in noi, esseri umani del XXI secolo, di antiche credenze, ataviche paure e remote speranze affidate a quella parte di pensiero irrazionale che chiamiamo superstizione
Condividi questo contenuto: