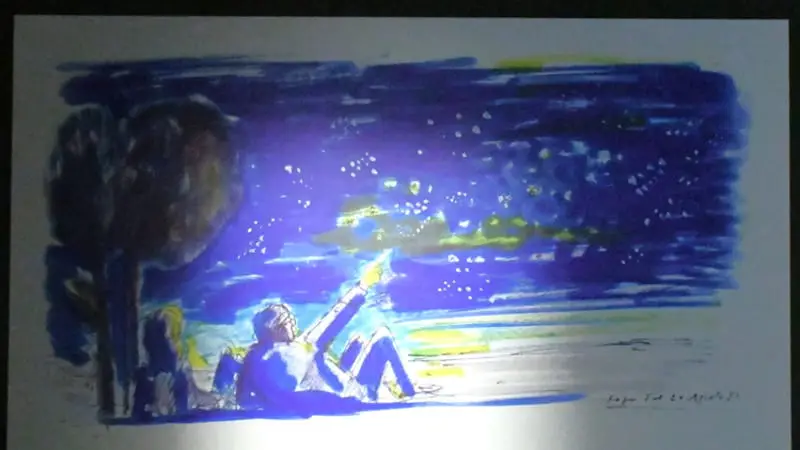Roosevelt, Dio patria e New Deal
L’articolo è uscito su Repubblica il 3 marzo 1993
Sono trascorsi sessanta anni e l’America ufficiale sembra non darsene pensiero. Il nome è riecheggiato talvolta durante la campagna elettorale delle ultime presidenziali, ma anche i luoghi degli Stati Uniti dove il ricordo sarebbe, per dir così, congeniale (le maggiori università, le città e i villaggi della vallata del Tennessee, le città “europee” della costa orientale, i quartieri negri e lo stesso partito democratico) stentano a ritrovare la memoria di Franklin Delano Roosevelt e del New Deal.
Eppure, il 4 marzo 1933, giorno del giuramento di Roosevelt, è una data fondamentale per gli Stati Uniti: iniziava la più lunga e drammatica presidenza della storia di questo paese e, come è stato detto, “un uomo aperto cominciava ad aprire l’America”. Ecco, questo “uomo aperto” che ha affrontato la più grave crisi del capitalismo moderno e poi la guerra decisiva per le sorti del nostro secolo, è stato lo statista coraggioso che ha sentito il dovere del governare e che, per la prima volta nella storia, ha dato un contenuto all’idea e alla pratica della democrazia.
Kupchan: “Trump non ha una strategia, così perderà il sostegno del Paese”
Se gli Stati Uniti non sentono l’ orgoglio e anche la responsabilità di avere, con Roosevelt e con il New Deal, raggiunto il punto forse più alto del loro cammino e se, in molte parti del mondo, si cerca ancora di capire che cosa è veramente la democrazia e quali siano i suoi istituti e i suoi metodi concreti, ignorando che in un tempo non lontano del Novecento la democrazia fu realmente instaurata e praticata, allora è giusto che l’ anniversario del 4 marzo 1933 passi in silenzio. D’altronde, l’opera di abrasione del rooseveltismo compiuta negli anni della guerra fredda (il maccartismo, ricordiamolo, è apparso proprio per liquidare le riforme politiche e sociali e la cultura democratica del New Deal) non poteva che raggiungere il culmine negli anni conservatori di Reagan e del suo epigono Bush.
Sessanta anni dopo, quindi, non saranno in molti a comprendere il senso storico dell’ “American dream” degli anni Trenta. Un esempio per tutti. Si è parlato, in questi giorni, in Italia del libro del politologo Giovanni Sartori (che insegna da anni negli Stati Uniti) dal titolo Democrazia. Cosa è (ed.Rizzoli). È un’opera questa che pretende di essere una puntuale ricerca storica (prende le mosse dal ‘700) e insieme teorica. Ebbene, Roosevelt e l’esperienza del New Deal non sono ricordati nemmeno in una sperduta nota a pie’ di pagina. Forse aveva ragione l’autore americano di un libello anti-rooseveltiano (pubblicato nel 1959 in Italia con il titolo, che dice molto, Lo stalinista Roosevelt) a scrivere con ironica sufficienza: “Il mondo risuona ancora dei nomi di Hitler e di Stalin, ma del presidente americano si sono perse le tracce”.
Cerchiamole dunque le tracce di Roosevelt e del “Brain Trust” che collaborò con lui dal 1933 al 1945 nella realizzazione di un progetto autenticamente politico di “trasformazione dei valori” della nazione americana. Cioè di una società e di un sistema sociale e culturale che si illudeva di avere raggiunto la perfezione della modernità e il massimo dello sviluppo. L’ allarme era stato dato, per la verità, già da qualche anno. Nel 1925 il filosofo John Dewey, padre del pragmatismo americano, aveva avvertito: “Le nostre istituzioni, democratiche nella forma, tendono in sostanza a favorire una plutocrazia privilegiata”. Erano gli anni del capitalismo ruggente e dell’ “orgia più costosa della storia” di cui scriverà Francis Scott Fitzgerald. Poco tempo dopo, uno dei paesi più ricchi del mondo era travolto da una schiera di politici corrotti, di speculatori, di banchieri disonesti e dai sogni artificiali di furbi e ingenui risparmiatori abbagliati dai rapidi guadagni.
Ebbene, il New Deal fu la risposta della ragione a questa follia, e fu il tentativo, realizzato già nei primi cento giorni della presidenza Roosevelt (e per coglierne lo “stile” si veda il primo decreto del New Deal che pubblichiamo in questa pagina) di sottomettere il modo di essere, di pensare e di produrre del capitalismo a delle norme di comportamento che salvaguardassero masse sterminate di cittadini impoveriti e miserabili, e insieme la dignità e i principi etici della democrazia e del buongoverno. Per raggiungere questo obiettivo Roosevelt organizzò la ripresa del sistema produttivo americano colpendo anzitutto il mondo della finanza e delle banche e scacciando “i mercanti dal tempio”; ma fece anche qualcosa di più avviando con decisione profonde riforme sociali nel pieno rispetto delle libertà civili e costituzionali. L’intensità e l’efficacia di questa combinazione tra “ripresa” e “riforma” sono dunque la chiave della democrazia rooseveltiana.
La “trasformazione dei valori” diviene così l’asse ideologico con il quale, rapidamente, si identificano una sorta di movimento di liberazione psicologica e culturale dei cittadini americani e un insieme di progetti riformatori di proporzioni mai viste prima. Sul piano culturale questo movimento dà il via a un processo di radicalizzazione intellettuale che vede contrapposti da una parte l’ottusa economia e dall’altra la democrazia politica come laboratorio di razionalità e di giustizia sociale. In termini concreti, Roosevelt non demonizzava il capitalismo ma voleva reinserirne le strutture economiche e la vitalità imprenditoriale in una democrazia “reale”, dove gli interessi collettivi non fossero piegati da minoranze di privilegiati e dal perverso e molecolare individualismo consumistico. Si trattava, insomma, di impedire (questo mi pare il nucleo teorico del New Deal) che il capitalismo degli “affari” e dei corrotti, si identificasse con l’ intera società. Questo progetto presupponeva, evidentemente, anche la pianificazione dell’ economia.
E Roosevelt dimostrò che questa “rivoluzione” era possibile. Ricordo solo il gigantesco piano della “Tennessee Valley Authority”. Cominciavano così a fondarsi anche gli istituti di un inedito capitalismo democratico. La scelta di Roosevelt non subì mai tentennamenti e il New Deal si presentò con quel volto della verità, semplice e necessaria, che conquistò il consenso della maggioranza degli americani. E infatti il presidente fu sempre rieletto in modo quasi plebiscitario. La iniziale, forte e impaurita opposizione conservatrice delle forze economiche, del Congresso e della Suprema Corte dovette ben presto ridimensionarsi.
La storia stava tranquillamente voltando pagina, come ricorderà Eleanor Roosevelt nelle sue memorie: “Quando mi volgo a guardare il passato, gli anni dal 1934 al 1936 mi appaiono come i più tranquilli e i meno ansiosi di quanti passammo alla Casa Bianca. Le riforme introdotte cominciavano a rimettere il paese in condizione di maggiore equilibrio; tra capitale e lavoro e tra presidente e Congresso esisteva, in generale, una buona armonia e nella nostra vita di famiglia eravamo riusciti ad adattare le nostre tradizioni e le nostre abitudini alle esigenze della Casa Bianca, formandoci il modello che seguimmo negli anni seguenti”.
Che fu, come è noto, un modello di eleganza, di sobrietà, di forte impegno morale. In altre parole, privato e pubblico si incrociavano e Roosevelt e il New Deal si penetravano l’ un l’ altro in modo emblematico, seguendo perfettamente la strada indicata nel discorso inaugurale del 4 marzo (“In cambio della fiducia avuta in me saprò dare il coraggio e la devozione che convengono al momento presente. E’ il meno che io possa fare”). Finalmente con Roosevelt il tradizionale rigore morale puritano usciva dal rispetto puramente formale e retorico della democrazia (“Ma la ricostruzione non esige solo modificazioni d’ indole morale. La nostra nazione domanda di poter agire, e immediatamente”) per diventare impulso alla riforma della società, e al rinnovo della identità e della legittimità delle classi dirigenti americane. Alle quali ora spettava l’ obbligo anzitutto di “abbandonare la falsa convinzione che i posti di alta responsabilità pubblica e politica si identificano con i fini dell’ ambizione e del profitto personale”. Ci sono, dunque, e fondate, le ragioni di un ricordo non frettoloso e superficiale di Franklin Delano Roosevelt e del suo giuramento fatto in una fredda giornata di marzo di sessanta anni fa.
Condividi questo contenuto: