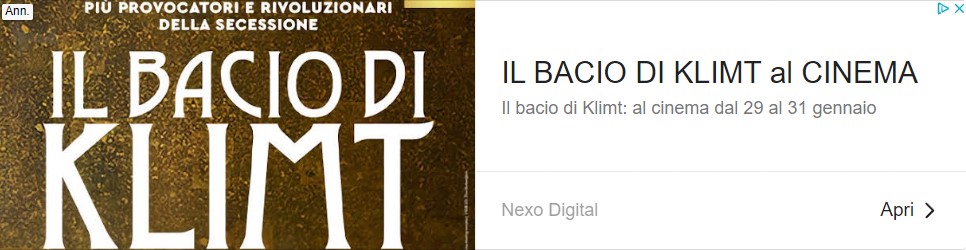Goldman Sachs: AI e data center accelerano il ritorno dell’atomo
Il nucleare torna protagonista nello scenario energetico mondiale. A riportarlo in primo piano è l’intreccio di due spinte potenti: la corsa all’intelligenza artificiale (AI), che sta facendo esplodere la domanda di elettricità, e l’urgenza di disporre di energia pulita, stabile e costante per sostenere la transizione ecologica. Goldman Sachs, nella sua ultima analisi sul mercato energy (“The New Nuclear Age: Why the World Is Rethinking Atomic Power”), parla apertamente di “nuova era dell’atomo”, destinata a ridefinire equilibri industriali e geopolitici.
Entro il 2050 i consumi mondiali di elettricità sono destinati quasi a raddoppiare. I soli data center, cuore pulsante dell’AI, potrebbero arrivare a richiedere 137 gigawatt di potenza già nel 2030, pari a un aumento del 165% rispetto a oggi. Circa il 60% di questa capacità dovrà essere coperta da nuova generazione. È qui che i grandi operatori digitali – Amazon, Microsoft, Google e Meta – hanno iniziato a guardare al nucleare come soluzione strutturale per i loro hub di intelligenza artificiale e cloud computing.
Gli accordi già firmati sono la prova concreta di questa svolta: Microsoft ha sottoscritto un PPA da 835 MW per riattivare la centrale di Three Mile Island, Amazon ha impegnato quasi 2 GW per i propri data center in Pennsylvania, mentre Meta ha siglato un contratto ventennale con la centrale di Clinton, Illinois. Dopo anni di crescita stagnante, il settore nucleare torna così a muoversi, sostenuto da investimenti cresciuti a un ritmo del 14% annuo nel periodo 2020-2024.
Alla Cop28, 25 Paesi si sono impegnati a triplicare la capacità nucleare entro il 2050; oggi sono già 31. Non solo governi: anche grandi istituzioni finanziarie e investitori privati stanno dirottando capitali verso nuove tecnologie atomiche, convinti che possano garantire sicurezza energetica, stabilità dei prezzi e riduzione delle emissioni.
Il quadro geopolitico, però, non è più quello degli anni Ottanta. Stati Uniti ed Europa hanno rallentato, lasciando campo libero a Cina e Russia. Pechino ha ormai quasi metà dei reattori in costruzione e punta a superare Washington come primo produttore entro il 2030, con l’obiettivo finale di raggiungere 200 GW al 2040. Mosca ha scelto una strada diversa: meno focus sul mercato interno, più influenza all’estero. Attraverso Rosatom, il Cremlino gestisce un portafoglio ordini da 200 miliardi di dollari, con 19 cantieri aperti in vari continenti e la capacità di offrire ai Paesi partner un pacchetto completo: tecnologia, costruzione, combustibile, gestione, smantellamento e soprattutto finanziamenti generosi.
Gli Stati Uniti provano a recuperare terreno. Il presidente Trump ha promesso di quadruplicare la produzione nucleare entro il 2050, con dieci nuovi grandi reattori in cantiere entro il 2030 e un piano di potenziamento da 5 GW sugli impianti esistenti. Ma la vera scommessa riguarda i Small modular reactors (Smr): unità fino a 300 MW, costruibili in fabbrica e assemblabili in loco, pensate per ridurre tempi e costi. Due progetti pilota sono già programmati: uno al Dipartimento dell’Energia nel 2027 e uno in una base militare nel 2028.
Gli Smr potrebbero rivoluzionare la fissione, rendendo più flessibile l’impiego e adattandola anche a utenze particolari come i data center. Restano però due nodi cruciali: i costi, con i primi prototipi in Russia e Cina che hanno registrato sforamenti del 300-400%, e il combustibile. Il nuovo Haleu, uranio arricchito fino al 20%, oggi è prodotto commercialmente solo da una controllata di Rosatom.
Accanto alla fissione, avanza la fusione, considerata la “stella polare” dell’energia del futuro. Produce quattro volte più energia della fissione e milioni di volte più dei combustibili fossili, senza i rischi di incidenti o proliferazione. Dopo la storica “ignition” ottenuta a Lawrence Livermore nel 2022, i progressi si susseguono: il reattore francese West ha mantenuto il plasma per oltre 22 minuti, record mondiale. Anche l’AI sta contribuendo, ottimizzando le simulazioni e accelerando i progetti.
Le prime applicazioni commerciali sono già in agenda. Microsoft ha firmato un contratto con Helion per un impianto da 50 MW entro il 2028, mentre Google ed Eni hanno siglato PPA da 200 e 400 MW con Commonwealth Fusion Systems, che punta a generare elettricità nei primi anni ’30.
La corsa alla fusione si gioca soprattutto tra Stati Uniti e Cina. Negli Usa la spinta arriva da start-up private – 25 delle 45 aziende mondiali censite dalla Fusion Industry Association sono americane – sostenute da capitali di venture e da investitori come Sam Altman o Bill Gates. In Cina, invece, è lo Stato a guidare il settore con 1,5 miliardi di dollari l’anno di finanziamenti, dieci volte i dottorati rispetto agli Usa e cantieri come il primo impianto ibrido fusione-fissione, previsto al 2030.
Le implicazioni geopolitiche sono profonde. Per i Paesi esportatori di petrolio e gas, dall’Arabia Saudita alla Russia, la crescita del nucleare potrebbe ridurre un pilastro della loro influenza globale. Per i grandi importatori, al contrario, significa più autonomia e meno vulnerabilità a crisi e volatilità dei prezzi. Non a caso, il Giappone ha già riavviato 14 reattori e punta al 20% di elettricità da nucleare entro il 2040. Il Regno Unito investirà 51 miliardi di dollari nella sua prima nuova centrale dal 1995.
Secondo Goldman Sachs, la rinascita dell’atomo è già iniziata. Ma la partita non si giocherà solo sulla capacità installata. A fare la differenza saranno catene di fornitura robuste, nuove regole di sicurezza, competenze tecniche e capitali disposti a sostenere progetti lunghi e complessi. In gioco c’è molto più della transizione energetica: è la mappa stessa del potere globale che rischia di cambiare.
Condividi questo contenuto: