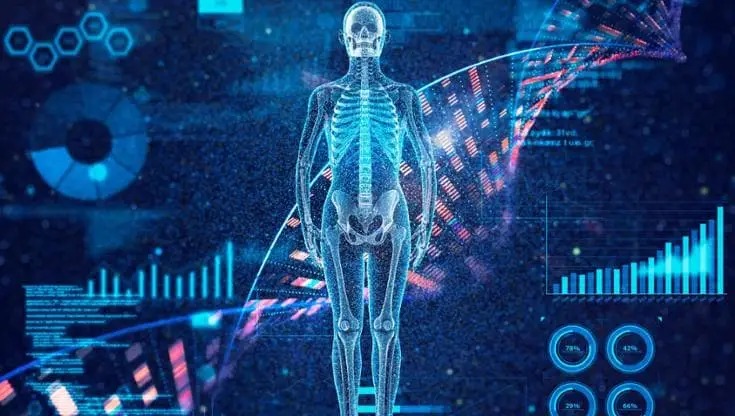Ai e genomica, una nuova alleanza per la medicina di domani
L’intelligenza artificiale applicata alla genomica sta aprendo la strada a una medicina sempre più personalizzata, capace di analizzare enormi quantità di dati biologici per identificare terapie mirate. Ma questa rivoluzione, lungi dal disumanizzare la cura, può paradossalmente accrescere la dimensione umanistica del rapporto medico-paziente. È uno dei temi centrali emersi nell’incontro “La vita che cura la vita. Biotecnologie, intelligenza artificiale, poesia”, appena svoltosi al Festival KUM! di Pesaro, ideato e diretto da Massimo Recalcati e promosso da Amgen. Scienziati, esperti di etica e letterati si sono confrontati su come cambia la diagnosi, la ricerca farmacologica e il concetto stesso di cura.
Chirurgia: l’I.A. ci dice come sarà il volto dopo l’intervento
Intelligenza artificiale con la genomica e per la diagnosi
La più significativa rivoluzione arriva dall’“abbraccio” tra intelligenza artificiale e genomica, lo studio del patrimonio genetico umano. Oggi è possibile attingere quantità enormi di informazioni da database genetici che raccolgono dati relativi a milioni di persone, per identificare le mutazioni all’origine delle malattie e sviluppare farmaci a bersaglio molecolare. L’intelligenza artificiale, che “si nutre” di dati, accelera questa analisi e supporta l’approccio secondo il quale “la vita cura la vita”, nel senso che sono proprio le risorse del corpo a essere usate per sviluppare nuovi trattamenti, come già avviene, per esempio, nel caso dell’immunoterapia. Poi c’è la diagnosi: in questo ambito l’integrazione tra esperto umano e intelligenza artificiale minimizza l’errore diagnostico, perché, come ha spiegato Vito Trianni, dirigente di ricerca all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche, “essere umano e macchina ‘sbagliano’ in maniera differente”, il che porta a una riduzione dell’“errore” complessivo. “La macchina non ragiona”, ha detto ancora lo scienziato, “ma intercetta la correlazione statistica tra sintomi e risultati, e produce un output che rappresenta il livello probabilistico più alto. Il medico, invece, ragiona sviluppando un pensiero ‘out of the box’, avendo cognizione di qual è lo stato del paziente, della sua storia, del suo vissuto, e in questo modo riesce a cogliere dettagli che difficilmente sono trasferibili tramite un prompt all’intelligenza artificiale”.
Il rischio di nuovi ictus o infarti a dieci anni? Lo dirà l’algoritmo per ogni paziente
Più tempo per la cura
L’intelligenza artificiale, liberando il medico da compiti meccanici e ripetitivi, può restituire ai sanitari la risorsa più preziosa, cioè il tempo della cura. Questa la tesi di Marcello Ianca, professore di Etica dell’intelligenza artificiale e delle neuroscienze all’Università tecnica di Monaco: “Automatizzando procedure burocratiche, triage ripetitivi o analisi di routine, gli algoritmi restituiscono a medici e infermieri ciò che è più prezioso, e cioè il tempo da dedicare all’ascolto, all’empatia e alla comprensione profonda dei pazienti”. Non solo: oltre a migliorare la qualità della cura, l’intelligenza artificiale può contribuire anche ad ampliarne l’orizzonte, rendendo accessibili in aree remote del mondo prestazioni diagnostiche di alto livello, grazie ad algoritmi di computer vision operativi su telefoni di vecchia generazione. I primi risultati sono già visibili: l’intelligenza artificiale ha portato a miglioramenti significativi della diagnostica in ambiti specifici come radiologia, dermatologia e diagnosi di tumori, dove la capacità di analizzare immagini ha condotto a strumenti che sono divenuti di utilizzo quotidiano. La prospettiva, ancora, è quella di una intelligenza artificiale utilizzata a supporto del medico – e non in sostituzione del medico – a cui resta in capo la responsabilità delle decisioni finali, con uno sviluppo di modelli specializzati solo nell’elaborare trattamenti in un determinato dominio terapeutico.
ChatGpt e la cura del cancro: Esmo lancia le prime Linee Guida
I limiti e il punto d’incontro
Anche un’epoca in cui le scelte collettive e personali saranno sempre più condizionate dagli algoritmi, dunque, la cornice “umanistica” resterà indispensabile nella medicina: l’intelligenza artificiale, dicono gli esperti, potrà elaborare miliardi di dati senza mai eguagliare la “sapienza” del medico nel cogliere la peculiarità dell’esperienza umana. “Questi strumenti”, ha affermato Valerio Magrelli, scrittore e docente, “procedono secondo il criterio della moltiplicazione dei dati, processati e incrociati il più rapidamente possibile. Ma, come ha detto lo scrittore Walter Siti, l’intelligenza artificiale non potrà mai creare un romanzo, perché non possiede un inconscio: l’iceberg che emerge per una piccola puntina è il pensiero cosciente, tutto il resto dell’essere umano è passioni, relazioni, connessioni sommerse. Ma anche nella ricerca genomica, come nella musica e nella poesia, si cercano in fondo sequenze e combinazioni da leggere e interpretare. Le due dimensioni della conoscenza, quella scientifico-tecnologica e quella estetica, sono meno lontane di quanto appaiano. Il punto d’incontro, forse, è nella capacità di intervenire sulla realtà. Il verbo greco poiein – fare, costruire, creare – indica l’agire umano, ma è anche la radice della parola poesia”.
Condividi questo contenuto: