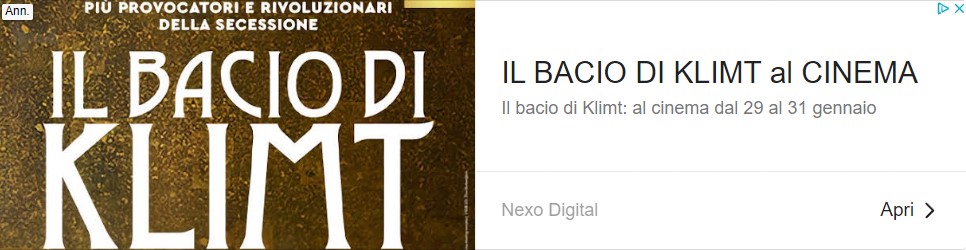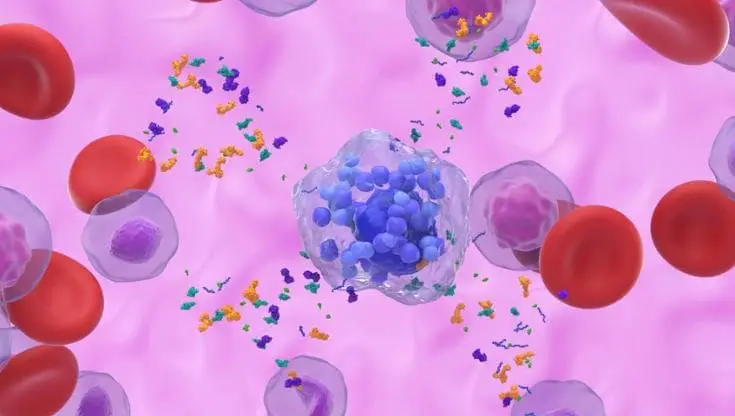Bonus psicologo: accolte solo l’1% delle richieste. La salute mentale non è un incentivo per la casa
L’anno scorso, per il Bonus Psicologo, sono arrivate oltre 400.000 domande all’Inps. Solo 3.325 persone hanno potuto ottenerlo: meno dell’1%. Non per mancanza di necessità, ma per mancanza di fondi. Quest’anno le risorse sono 9,5 milioni di euro.
Facendo due conti, significa che, a contributo massimo di 1.500 euro a persona, potranno beneficiarne circa 6.300 cittadini. Se le richieste saranno anche solo pari a quelle del 2024, la stragrande maggioranza resterà fuori. E qui sta il nodo: la salute mentale non è un “bonus” come quello per rifare il tetto o cambiare gli infissi. Non è un incentivo straordinario che si esaurisce a metà mese lasciando centinaia di migliaia di cittadini in lista d’attesa.
Un diritto per tutti
È un diritto, e come tale dovrebbe essere trattato. I numeri ci raccontano un bisogno gigantesco e strutturale: in Italia il 28% della popolazione soffre di disturbi mentali, oltre 16 milioni di persone e ogni giorno circa 1.571 persone si recano in pronto soccorso per problemi di salute mentale. Tra i giovani, 1 minore su 5 presenta un disturbo psicologico e negli ultimi dieci anni gli accessi in pronto soccorso pediatrico per motivi psichiatrici sono aumentati del 500%.
Bonus psicologico, 9 pazienti su 10 si sentono meglio dopo la terapia
E questo è solo ciò che emerge dai dati ufficiali: quante altre persone, scoraggiate dalla burocrazia o dalla consapevolezza che “tanto i fondi finiscono subito”, rinunciano ancora prima di provare? Poi c’è un aspetto di cui si parla pochissimo: il punto di vista dello psicologo.
Poco tempo per il paziente
Perché il bonus, così com’è strutturato, mette il professionista in una posizione eticamente insostenibile. Significa sedersi di fronte a un paziente, iniziare un percorso terapeutico, creare una relazione di fiducia… e a un certo punto dire: “Mi dispiace, ma dobbiamo interrompere. Il budget è finito”.
Come se il dolore o la sofferenza potessero essere messi in pausa. Come se la depressione, l’ansia, il trauma potessero capire che “quest’anno non ci sono più fondi” e aspettare il prossimo bando. In psicologia, l’interruzione forzata non è neutra: può riattivare ferite profonde, alimentare la sfiducia, rinforzare la convinzione di “non valere abbastanza” da meritare aiuto.
È l’opposto di ciò che dovrebbe accadere in un percorso di cura. Ben venga ogni finanziamento, certo. Ma se ogni anno abbiamo centinaia di migliaia di persone che chiedono aiuto e ne aiutiamo solo poche migliaia, significa che non stiamo affrontando un’urgenza sanitaria: la stiamo arginando con un cerotto simbolico.
Una questione di sanità pubblica
La psicologia non può essere trattata come un’elemosina istituzionale. Deve diventare parte stabile della sanità pubblica, con accesso garantito e tempi rapidi. Perché quando la mente crolla, non si può aspettare l’apertura del prossimo bando. E nessuno psicologo e nessun cittadino dovrebbero trovarsi in questa condizione. Quando la mente è in crisi, non basta ristrutturare la casa: serve aprire una porta. E dietro quella porta ci deve essere qualcuno che resta, finché serve.
Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, presidente Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo “Di.Te”, docente di Psicologia delle Dipendenze Tecnologiche Università E-Campus Docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni Università Politecnica delle Marche
Condividi questo contenuto: