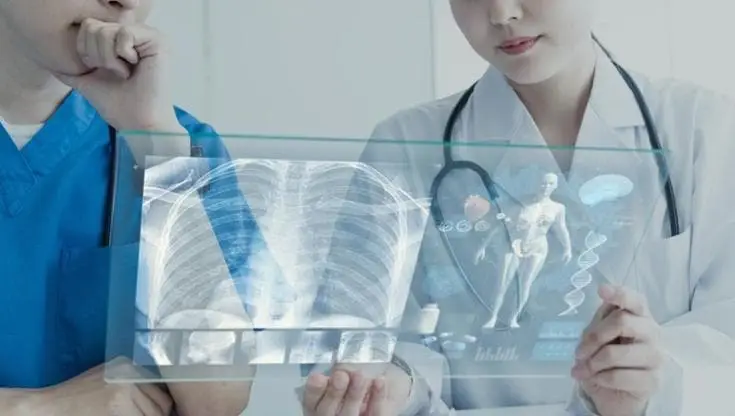Dati certi e verificabili: ecco il motore della medicina che ci cura
Nell’era della medicina di precisione, delle nuove tecnologie diagnostiche e dell’Intelligenza Artificiale i dati rappresentano un elemento imprescindibile. Non solo perché consentono di sviluppare terapie e vaccini innovativi, come si è visto durante la pandemia di Covid-19, ma soprattutto perché offrono un fondamento solido – verificabile e condivisibile – alle decisioni cliniche. Senza dati affidabili la medicina rischia di smarrire la sua natura scientifica, confondendosi con pratiche prive di evidenza o, peggio, ingannevoli.
Medicina scientifica e illusioni magiche
A spiegarlo è Lorenzo Montali, Presidente del Cicap, organizzatore del Cicap Fest, il festival della scienza e della curiosità, che si è svolto a Padova dal 14 al 16 novembre. “Ci sono due considerazioni – spiega -. La prima considerazione riguarda la distinzione tra medicina scientifica e proposte terapeutiche che, invece, non hanno alcun fondamento nei dati. E’ significativo l’esempio drammatico dei genitori veneti che hanno creduto alla cosiddetta nuova medicina germanica, secondo cui la malattia non esiste come fatto organico, ma è un’invenzione del nostro cervello. Hanno così rinunciato a curare figlio, che poi è deceduto”.
“Il problema è distinguere ciò che si fonda su studi, evidenze e dati da ciò che viene presentato come terapeutico senza alcun supporto scientifico, ma fondato su principi magici”, ha evidenziato Montali, tra gli ospiti del panel dal titolo “Non solo numeri, cosa raccontano i dati”. Lì si è dibattuto proprio del ruolo dei dati in rapporto alle scienze, ma anche di come possano influenzare certe scelte.
“La seconda considerazione riguarda l’uso corretto dei dati nella medicina scientifica. Uno studio singolo non può, da solo, ribaltare ciò che sappiamo: ogni esperimento ha limiti metodologici, può contenere errori, dipende dal campione e dagli strumenti utilizzati. La scienza procede per accumulazione e validazione indipendente: una scoperta è tale quando altri laboratori la replicano”.
Il boom delle informazioni
Ma, se viviamo in un mondo in cui siamo sommersi dai dati, esiste il rischio di fidarsi ciecamente delle informazioni, senza comprenderne la qualità o il metodo con cui vengono raccolte? “Da una parte, sentiamo l’esigenza di informazioni per prendere decisioni che riguardano la nostra vita in mille campi: salute, alimentazione, scelte scolastiche o professionali. Dall’altra parte, riceviamo come mai prima d’ora una quantità enorme di informazioni, che arrivano da una pluralità di fonti e sulle quali abbiamo pochissimo controllo”.
Il problema – sottolinea – non si risolve immaginando che si possa diventare esperti di tutto, dalle malattie rare alle terre rare: non è realistico. “Si tratta, invece, di diffondere una conoscenza dei metodi della scienza e dei processi attraverso cui si arriva a definire una verità scientifica. Questo atteggiamento dovrebbe entrare nel sistema educativo. Non serve più informazione, serve maggior ragionamento”, evidenzia Montali, convinto sostenitore dell’allenamento al pensiero critico in età scolare.
Il pericolo del pregiudizio
E’ proprio negli anni della formazione, infatti, che si delinea quel pregiudizio che allontana bambine e ragazze dalle materie scientifiche. Pregiudizio che, poi, ha pesanti conseguenze nelle scelte professionali future e persino nelle scelte personali e familiari. Si tratta, quindi, di un problema culturale o scolastico? “È appena uscito uno studio su Nature che ha preso in esami circa 2,6 milioni di bambini e bambine francesi: è emerso che già dal quarto mese del primo anno scolastico si crea un gap nelle competenze matematiche che si mantiene nel tempo, pur partendo da competenze iniziali uguali. Questo dipende da una stereotipia di genere: una percezione sociale secondo cui le bambine sarebbero meno adeguate per certi compiti”.
Non si tratta di un problema solo italiano, né recente: è internazionale e antico, anche se oggi c’è maggiore consapevolezza. “Il risultato – osserva Montali – è che le donne, pur rappresentando la maggioranza negli studi universitari, diminuiscono nelle carriere cosiddette Stem. E come società perdiamo la possibilità che riescano a mostrare le loro competenze”.
Il Festival e le sue origini
Il Cicap Fest venne creato da un grande giornalista e divulgatore della scienza, Piero Angela, e il lavoro di Montali in questo edizione si è riallacciato all’idea originaria del fondatore. “Il filo conduttore è stata l’idea dello sconfinare e dell’avventura. La scienza avanza abbandonando certezze consolidate per cercare il nuovo. Allo stesso modo, ciascuno di noi può abbandonare i propri confini grazie alla curiosità. Quando Piero Angela creò il Cicap Fest, diceva: “Ci interessa parlare alle persone che vogliono conoscere, non solo credere”. Conoscere significa mettere in discussione ciò che sappiamo, con lo spirito dell’avventura. Non sai se otterrai ciò che cerchi, ma la curiosità ti spinge avanti”.
Condividi questo contenuto: