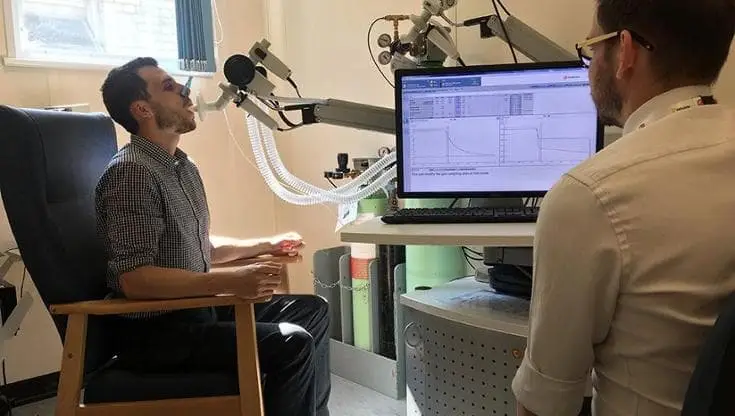IPF, speranze da una nuova cura per la malattia che toglie il fiato e attacca il cuore
All’inizio, la difficoltà a respirare compare dopo uno sforzo. Poi, progressivamente, la dispnea si manifesta anche a riposo. Ed arriva la tosse, secca, difficile da controllare, con le dita che possono assumere la classica forma “a bacchetta di tamburo”. Così si può prendere la strada verso l’insufficienza respiratoria con conseguente sofferenza per polmoni e cuore in chi soffre di fibrosi polmonare idiopatica (o IPF, acronimo dell’inglese Idiopathic Pulmonary Fibrosis). Per chi soffre di questa malattia rara (incidenza circa 20/100.000 nei maschi;13/100.000 nelle donne) ma il cui riscontro sembra essere in aumento, la ricerca propone prospettive di trattamento importanti. Lo dimostrano i risultati degli studi di fase III FIBRONEER™-IPF e FIBRONEER™-ILD, che hanno valutato nerandomilast, un farmaco sperimentale orale che agisce inibendo la fosfodiesterasi 4B (PDE4B) sperimentale per via orale, in studio rispettivamente nei pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF) e fibrosi polmonare progressiva (PPF), con e senza terapia antifibrotica di base.
I risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine e presentati come dati late-breaking alla Conferenza internazionale dell’American Thoracic Society (ATS) del 2025.
Scompenso cardiaco, due malati su 5 non si fanno visitare ogni anno (ed è indispensabile)
Cosa emerge dalla ricerca
Nerandomilast è un farmaco sperimentale il cui uso non è stato ancora approvato. Le sue efficacia e sicurezza non sono ancora state definite. Tutti e due gli studi hanno soddisfatto l’obiettivo primario con entrambe le dosi, 9 e 18 milligrammi, valutato mediante la riduzione della variazione assoluta della capacità vitale forzata (FVC) dal basale alla Settimana 52 rispetto al placebo. La FVC è una misura della funzionalità polmonare.

“Dopo diverse prove nella comunità scientifica per portare avanti nuovi dati clinici, IPF e PPF continuano ad avere conseguenze devastanti per i pazienti – ha dichiarato Toby Maher, M.D., Ph.D., Professore di Medicina Clinica, Keck School of Medicine, USC Los Angeles. Avere due studi di fase III che raggiungono l’endpoint primario è una svolta importante per la comunità scientifica, e evidenziano che nerandomilast potrebbe avere un impatto significativo sui bisogni insoddisfatti dei pazienti, sia in monoterapia che in combinazione con i trattamenti attuali”. In entrambi gli studi sono stati osservati bassi tassi di interruzione definitiva del trattamento: nello studio FIBRONEER™–IPF, gli eventi avversi hanno portato all’interruzione definitiva del regime in studio nel 14.0% dei pazienti nel gruppo nerandomilast 18 milligrammi, nel 11.7% dei pazienti nel gruppo nerandomilast 9 milligrammi e nel 10.7% dei pazienti nel gruppo placebo. Nello studio FIBRONEER™-ILD, gli eventi avversi hanno portato all’interruzione definitiva del regime in studio nel 10% dei pazienti nel gruppo nerandomilast 18 milligrammi, nel 8.1% dei pazienti nel gruppo nerandomilast 9 milligrammi e nel 10.2% dei pazienti nel gruppo placebo. In entrambi gli studi non sono stati registrati squilibri tra i gruppi nerandomilast e placebo in relazione agli eventi avversi di interesse, come vasculite, depressione o altre condizioni.
Il cuore non ce la fa? Ecco quali sono i meccanismi invisibili che portano allo scompenso cardiaco
Cosa sono le interstiziopatie e cos’è l’IPF
La malattia fa parte delle cosiddette “interstiziopatie polmonari” o “pneumopatie diffuse infiltrative”. Si tratta di patologie del parenchima polmonare (la parte dedicata agli scambi dei gas fra aria e sangue) caratterizzate da accumulo improprio di cellule o sostanze extracellulari in queste zone. In pratica il contrario di quanto avviene nell’enfisema (una malattia che si ha per “scomparsa” di tessuto polmonare dedicato agli scambi gassosi).
In questo gruppo rientra un numero enorme di entità patologiche la cui causa può essere nota, può essere chiara una associazione con malattie sistemiche (i polmoni rappresentano solo uno – anche se a volte il principale – degli organi coinvolti), entità in cui è stata identificata una mutazione genetica o infine possono essere idiopatiche (malattie di cui non si conosce la causa).
Tutte queste condizioni hanno in comune alterazioni funzionali dell’organo: riduzione della capacità di mobilizzare volumi d’aria durante gli atti respiratori, quindi deficit restrittivo, riduzione dell’ossigeno nel sangue sotto sforzo o, nelle fasi più avanzate, a riposo. Di molte si conosce la cura, di altre si hanno farmaci in grado di interrompere la evoluzione verso la insufficienza respiratoria; infine in un numero minore di malattie si conoscono solo cure in grado di ridurne il declino funzionale o si deve, quando possibile, ricorrere al trapianto polmonare. La fibrosi polmonare idiopatica fa parte di questo ultimo gruppo.
Scompenso cardiaco grave, le cellule del cuore potrebbero “autoripararsi” con un “aiuto” tech
Condividi questo contenuto: