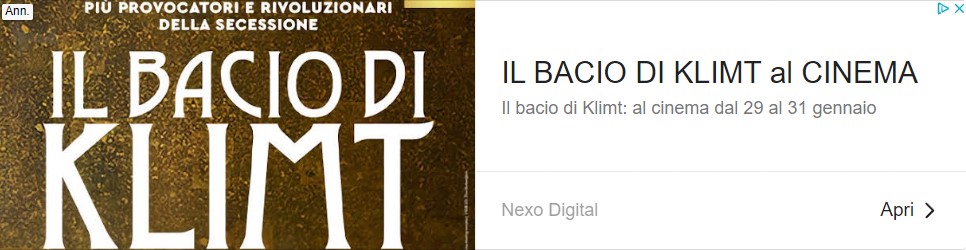Persone LGBTQ+, contro i tumori serve una comunicazione più inclusiva
“Le barriere sono invisibili alla maggior parte delle persone. Eppure sono enormi, tanto che è difficile credere che dipendano solo dalle parole che usiamo, dal colore scelto per una brochure o da un’immagine. Ma, se la nostra comunicazione risulta poco comprensibile al pubblico cui è rivolta, le persone faranno molta fatica ad accedere alle cure: a partecipare agli screening, a seguire le terapie, a fare i controlli necessari. E le conseguenze sulla salute dei pazienti, queste sì, le vediamo tutti”. Chiara Cassani, ginecologa oncologa al Policlinico San Matteo e ricercatrice dell’Università di Pavia parla – dati alla mano – di disuguaglianze e iniquità: quelle legate al genere, all’identità di genere, all’età, alla lingua, alla religione, alla situazione sociale, economica e culturale. In una parola, alle minoranze.
Sono tutte iniquità che – dice – si moltiplicano, fino a diventare un problema di Sanità pubblica non così marginale come si potrebbe pensare. Ecco perché, insieme con un gruppo di ricercatori di diverse realtà lombarde, Cassani è alla ricerca di soluzioni per aumentare l’inclusione.
La newsletter di Oncodonna
È partito da pochi giorni, infatti, il progetto ICaRe, che ha l’obiettivo di combattere le disuguaglianze in oncologia e che la vede coinvolta come principal investigator: un programma di ricerca che sarà finanziato con 200 mila euro grazie alla call “Inequalities Research” di Fondazione Cariplo, che coinvolge (tra gli altri) l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’Irccs Maugeri Pavia, la Fondazione Cnao e anche il Dipartimento di Linguistica dell’ateneo pavese. Già, perché il focus sulla comunicazione è la peculiarità di questo progetto.
Oncologia, 10 raccomandazioni per tenere conto dell’identità di genere
Da dove nasce il progetto
“L’idea nasce da una consapevolezza acquisita giorno dopo giorno nel nostro lavoro – racconta a Salute Cassani – Molte delle nostre comunicazioni risultano spesso poco chiare. In particolare, dalla ricerca nazionale e internazionale emerge che uno degli aspetti più critici riguarda la comunicazione nei confronti di tutta quella popolazione, sempre più ampia, che si identifica come minoranza per l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Che, di conseguenza, ha più difficoltà nell’accesso alla prevenzione e alle cure ed ha esiti peggiori quando trattata per un tumore. Il fatto che un problema di comunicazione si traduca in un diverso esito delle cure non è ammissibile”.
Tumore al seno, quale screening per le persone transgender?
Una comunicazione gender-oriented
Qualche esempio può aiutare a capire. Pensiamo al materiale informativo sull’importanza dello screening per il tumore al collo dell’utero e della vaccinazione anti-Hpv che possiamo trovare in giro, magari dal medico di famiglia o in un qualsiasi ambulatorio. Di solito il colore predominante è il rosa e il pronome utilizzato è lei. Se su due piedi viene da pensare “ovvio”, vuol dire che non si sta prendendo in considerazione il fatto che un uomo transgender – che ha l’utero in sede – abbia la necessità, nonché il diritto, di fare prevenzione. Se quella persona è registrata all’anagrafe come uomo, non verrà neanche chiamata dal servizio di screening regionale: diviene invisibile. Lo stesso vale per la comunicazione alle donne transgender per quanto riguarda il rischio di tumore della prostata. E, in caso di cure ormonali, per quello del seno.
Infezioni da Hpv e tumori testa-collo: verso un test per la diagnosi precoce
La privacy per la vaccinazione Hpv negli uomini
Un altro caso ancora. Quello di Giulio (nome di fantasia) che dovrebbe accedere alla vaccinazione anti-Hpv, prevista gratuitamente per gli uomini che fanno sesso con uomini (MsM), un comportamento correlato a un aumento del rischio di infezione da Hpv e, quindi, di alcuni tumori, al pari delle donne che fanno sesso con uomini). Qui, oltre al gap della comunicazione, esiste un questione di privacy: per accedere alla prevenzione, Giulio deve dichiarare il suo orientamento sessuale. Altrimenti se la deve pagare. Ed ecco che subentra un’altra iniquità, cioè la discriminazione nell’accesso alle cure in base al reddito: si protegge solo chi se lo può permettere. “Questo è un chiaro esempio di come più fattori possano intersecarsi – fa notare Cassani – Se lo stigma e la discriminazione dell’orientamento sessuale si prepetuano, chi ha meno risorse, non solo economiche ma anche culturali e sociali, farà più fatica ad andare dal medico anche in presenza di sintomi, e la diagnosi di tumore arriverà in uno stadio già avanzato, quando le possibilità di cura sono più limitate. È una cosa che vediamo accadere”.
Donne migranti, per il tumore del collo dell’utero l’incidenza è doppia
Un modello inclusivo e replicabile
Altre disuguaglianze possono riguardare la religione: in alcune popolazioni di donne, per esempio, le malattie legate alla sfera sessuale sono un argomento molto delicato. Bisogna saper porre le domande nel modo giusto, ci dice Cassani, perché il linguaggio scelto può fare la differenza. “In generale, non siamo abituati a relazionarci con riferimenti culturali diversi da quelli in cui siamo cresciuti. Adattare la comunicazione non è una capacità innata, ma bisogna formarla, o rischiamo di generare noi stessi delle disuguaglianze. Purtroppo nei corsi universitari di Medicina lo studio della comunicazione in ambito sanitario è ancora una Cenerentola. Noi vogliamo sviluppare un modello che sia davvero inclusivo e replicabile, anche al di fuori dell’ambito oncologico”. Per questo la formazione del personale sanitario è una parte integrante del progetto ICaRe. Esperienze simili sono state fatte soprattutto nel Regno Unito, nei Paesi del Nord Europa e, almeno fino a poco tempo fa, negli Usa.
Tumore al collo dell’utero nelle donne over 65: bisogna estendere lo screening?
Le fasi dell’iniziativa
Si parte dalla raccolta del materiale informativo – da quello nei Day Hospital alle campagne di sensibilizzazione – che verrà analizzato con l’aiuto sia dei linguisti sia di esperti di comunicazione in ambito medico e di studi di genere, sia da rappresentanti delle minoranze e delle associazioni di pazienti. “Un’alleanza strategica che mira a promuovere un cambiamento culturale e strutturale nel modo in cui le informazioni sanitarie vengono trasmesse e recepite dai pazienti”, commentano Amelia Barcellini radioterapista oncologa di Fondazione Cnao e dell’Università di Pavia e Laura Deborah Locati dell’Irccs Maugeri Pavia e professore associato di Oncologia medica dello stesso ateneo. Un ulteriore valore aggiunto di ICaRe è il coinvolgimento di giovani ricercatrici, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e lo sviluppo professionale.
Passeggiare dentro “Le quattro stagioni” di Vivaldi durante la chemio. Con la realtà virtuale
Cassani e colleghi contano di avere i primi risultati per l’inizio del nuovo anno: “Questi dati – conclude la ricercatrice – ci indicheranno le aree e i gap su cui focalizzarci. Poi costruiremo e testeremo i nuovi modelli in un vero e proprio studio clinico. Alla fine, organizzeremo dei working group per diffondere buone pratiche di comunicazione”.
Condividi questo contenuto: