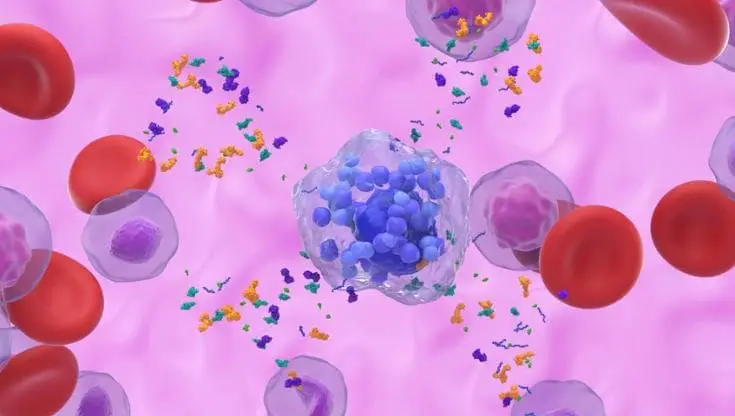Sara Anceschi: “La mia storia comincia con l’adozione. Oggi non guardo più indietro”
Quando le chiedono di raccontarsi, Sara Anceschi non comincia dall’adozione. Parla dell’amore che oggi le riempie la vita. “Mi chiamo Sara, ho 41 anni, sono un’insegnante e la mamma di Mattia e Sofia. Loro sono il sogno che ho sempre portato nel cuore. La mia storia è nata grazie all’adozione, ma non si esaurisce in quella parola: è andata avanti, si è intrecciata con altre vite, ha messo radici, ha generato futuro”.
Nel 1984 è stata abbandonata a Salvador de Bahia, in Brasile, su una panchina, avvolta in un asciugamano, davanti a un orfanotrofio. “Non so il giorno preciso in cui sono nata. Ma so quando sono diventata figlia”, racconta. Sara è stata adottata a pochi mesi da Anna e Giancarlo, una coppia italiana partita da Torino con in mano una fotografia in bianco e nero: il primo sguardo sulla figlia che li stava aspettando dall’altra parte del mondo.
Negli anni Ottanta, in Italia, le adozioni internazionali erano ancora rare. Le famiglie con figli di origine non europea attiravano curiosità, incomprensioni, a volte pregiudizi. “Abbiamo vissuto episodi di razzismo e ignoranza,” racconta Sara. “C’era chi chiedeva ai miei genitori se sapessi parlare italiano, o che cosa mangiassi, come se fossi una aliena. Alcuni commenti erano solo goffi. Altri lasciavano il segno. Ma i miei genitori mi hanno sempre colmata d’amore. E in quell’amore io non ho mai sentito di avere qualcosa in meno”.
Alice Degradi: “Il diabete non mi ha fermata. Ora gioco nella Nazionale di pallavolo”
Il viaggio verso il Brasile
Dopo la laurea, con una tesi sull’adozione internazionale e decine di incontri con famiglie adottive alle spalle, Sara sentì il bisogno di completare un pezzo della sua storia, così, a 23 anni, prese un volo per il Brasile. “Non cercavo una persona, né risposte”, racconta. “Volevo solo dare corpo ai racconti che per vent’anni avevano abitato le parole dei miei genitori. Aggiungere una geografia alla mia storia”.
E invece, quel viaggio le restituì molto più di una mappa. “A Salvador de Bahia mi sono sentita straniera. Guardata, scrutata. Come mai mi era successo in Italia. Ma è stato anche un viaggio che mi ha permesso di fare pace — almeno in parte — con la figura della donna che mi ha messa al mondo. Camminando tra le favelas, ho pensato che forse, nel suo gesto, c’era una forma di amore. Un pensiero silenzioso. Una speranza”.
Oggi, da madre, quella domanda che allora aveva tenuto a distanza riaffiora, più forte, più urgente: “Come si fa a lasciare andare una figlia, dopo averla sentita crescere dentro di sé? Dopo averla stretta tra le braccia?”. Non c’è una risposta. “Ma quella domanda, oggi, non fa più male”. Anche perché capisce quanta sofferenza ci sia stata dietro quell’abbandono.
È diventata parte di lei. “Una domanda che non cerca più di essere risolta, ma accolta”. E presto, quel viaggio lo farà di nuovo. “Vorrei tornare in Brasile con mio marito e i miei figli. Sarà un viaggio per loro. Perché possano vedere il paese di cui tanto parliamo, a cui — in qualche modo — sentono di appartenere. Per costruire insieme, come famiglia, nuovi intrecci di senso”.
Aurora: “A 16 anni l’anoressia, un disturbo vissuto in solitudine. Ora sto bene e aiuto gli altri”
Le etichette che restano
Anche oggi, che è madre e adulta, gli sguardi e le domande non mancano. “I miei figli, Mattia e Sofia, sono nati dalla mia pancia. Ma hanno la pelle chiara, gli occhi verdi, i capelli biondi. È capitato che mi chiedessero se fossi la tata”.
Parole che un tempo avrebbero ferito. Oggi no. “Abbiamo sempre frequentato ambienti multiculturali e famiglie adottive, perché i nostri figli sapessero che la nostra non è l’unica famiglia colorata al mondo. Per loro io sono la mamma, e basta. Anche se fossi blu o verde, non cambierebbe nulla”. Nel 2020, Sara ha deciso di affidare la sua voce alla scrittura. Ne è nato un libro: Mamma, tu in che pancia sei nata? (ETS), titolo nato da una domanda ingenua e luminosa di suo figlio Mattia.
Mark, il fratello di Jannik Sinner
“Sull’adozione parlano in tanti: psicologi, giudici, genitori. Ma chi racconta dal punto di vista di un figlio? Noi, adottati negli anni Ottanta, oggi siamo adulti. E possiamo finalmente dire come l’abbiamo vissuta”. Negli ultimi anni, Sara ha portato la sua testimonianza in scuole, teatri, biblioteche.
“Il mio desiderio è che un giorno non serva più spiegare chi siamo. Che i figli adottati siano semplicemente figli. E i genitori adottivi solo genitori. Senza aggettivi, senza asterischi, senza note a piè di pagina che giustifichino la composizione di una famiglia – come se l’amore, da solo, non bastasse a definirla. Vorrei, ad esempio, che Mark, il fratello di Jannik Sinner fosse semplicemente suo fratello. Non il fratello adottivo. Perché ogni volta che si sente il bisogno di aggiungere una specifica — “adottivo”, “biologico”, “naturale” — si crea una distanza. Una sottile linea di separazione che dice: sei qualcosa di simile, ma non proprio. Quasi, ma non del tutto”. E invece no. “Io non voglio che nessun bambino cresca con la sensazione di essere un’eccezione alla regola. I figli sono figli. E basta”.
L’adozione non è un trauma
Secondo Sara, “l’adozione è una delle eventualità della vita: può segnarti, lasciare tracce profonde, darti un’opportunità, ma non per questo definisce tutto quello che sei. Eppure, è come se noi adottati portassimo una targa cucita addosso per sempre, come se quell’aggettivo – ‘adottato’ – dovesse seguirci in ogni fase della vita, anche quando siamo diventati adulti, genitori, altro”.
E aggiunge: “L’adozione può essere faticosa. Soprattutto oggi, perché i bambini adottati non sono più – come spesso accadeva un tempo, e come è successo a me – neonati da crescere fin dall’inizio, ma bambini e ragazzi più grandi, che arrivano con una storia alle spalle e portano con sé memorie, talvolta traumi importanti”. Eppure, conclude, “può anche essere una grandissima occasione. Per questo mi ripeto che l’adozione non va romanticizzata. Ma nemmeno patologizzata”.
Condividi questo contenuto: