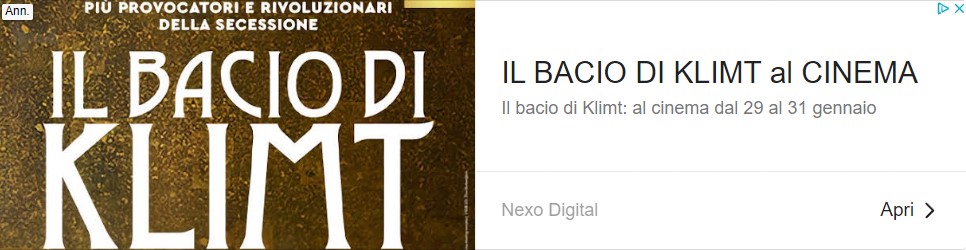I segreti del Conclave nei tre libri in regalo con Repubblica
Si racconta che i cardinali presenti al secondo Concilio di Lione rimasero spiazzati quando papa Gregorio X presentò loro, il 7 luglio 1274, la bozza di un documento dal titolo inquietante: Ubi periculum. In effetti il pericolo l’avevano appena sperimentato. Dopo la morte di Clemente IV, avvenuta il 29 novembre 1268, i 19 elettori non trovavano accordo, il popolo esasperato li segregò, loro reagirono scomunicando. E nel frattempo la Chiesa cattolica rimase senza pontefice per quasi tre anni, esposta alle pressioni esterne e alle contese interne. Non poteva accadere di nuovo.
Verso il Conclave: le news di oggi
Gregorio stilò una serie di regole per arrivare alla scelta dei suoi successori. Calendario serrato, addirittura razionamento del cibo: dopo tre giorni solo una portata, dopo altri cinque solo pane, acqua e vino. I porporati non la presero bene, tentarono di ribaltare il Concilio contro il Papa. Furono però respinti: gli ecclesiastici privi di porpora si schierarono quasi unanimi col pontefice. E nacque il conclave.
A distanza di quasi otto secoli tutto si consuma in pochissimo tempo, dopo tre settimane dalla morte di un papa in genere se ne fa un altro. Eppure, attorno a quei giorni densi di avvenimenti vaticani continuano a fiorire letteratura, suggestioni cinematografiche, attenzione mediatica, con un corollario di lessico, simboli e segni. Nei tre volumi in edicola gratis con Repubblica domani, lunedì 5 e martedì 6 maggio, Agostino Paravicini Bagliani e Maria Antonietta Visceglia guidano alla scoperta delle origini e del significato di riti e regole del conclave. Come la restrizione approvata per evitare le ingerenze politiche sulle scelte dei cardinali. È questione recente, di appena dieci papi fa: alla morte di Leone XIII, l’autore dell’enciclica sociale Rerum novarum, l’imperatore d’Austria pose il veto sull’elezione pontificia del segretario di Stato uscente, Mariano Rampolla. Fu il cardinale di Cracovia Jan Pawel Puzyna, il 2 agosto 1903, a leggere il veto exclusionis, pronunciato jure et privilegio antiquo. Passò alla storia come il «fatto doloroso». E una volta avvenuta l’elezione del papa Giuseppe Sarto, Pio X, si comprese che era arrivato il momento di una nuova riforma radicale. Si occupò di studiare la pratica il monsignore Pietro Gasparri, che diventerà poi sotto Pio XI il regista dei Patti lateranensi, insieme a un giovanissimo Eugenio Pacelli, che sarà papa Pio XII.
Da questo intreccio di personalità del secolo breve nacque il testo che abolì il veto esterno delle cancellerie, limitando di fatto il potere di interferenza dei potentati politici agli endorsement velati o ad altri espliciti, come quello rimbalzato in questi giorni sul Vaticano dalla Casa Bianca. Ma Pio X fece un ulteriore passo avanti, confezionando una riforma complessiva in virtù della quale Paravicini Bagliani e Visceglia concordano con Alberto Melloni nel dire che papa Sarto «nella sua produzione normativa segna il passaggio dalla tradizione alla modernità». È con lui, insomma, che al netto di emendamenti dei successori prende forma la votazione a cui assisteremo a partire dal 7 maggio.
Il resto è storia, affascinante e intrigante quanto l’attualità di questi giorni Oltretevere. Perché è suggestivo pensare che un tempo il papa appena eletto si insediava sulla cattedra in Laterano – tuttora la sua sede come vescovo di Roma – sedendo prima su un seggio definito stercotario per evocare proprio il letame, perché al culmine della gloria il neo-pontefice ricordasse l’umiltà. E a rafforzare il concetto si aggiungeva il rito della stoppa, accesa “affinché si spenga immediatamente”. In relazione a questo gesto, scrivono Paravicini Bagliani e Visceglia, Stefano de Borbone usa per la prima volta le parole Sic transit gloria mundi. Quella che non passa mai, invece, è la curiosità per ciò che avviene in Sistina dopo l’extra omnes.
Condividi questo contenuto: